Lettura della lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli,
davanti alla promessa di Dio, Abramo non esitò,
non gli mancava la fede,
ma trovò la sua forza nella fede
e diede gloria a Dio,
perché era pienamente convinto
che Dio ha il potere di realizzare ciò che ha promesso.
Ed è per questo che
gli fu concesso di essere giusto.
Dicendo che gli era stato concesso,
La Scrittura non è interessata solo a lui,
ma anche a noi,
perché ci sarà concesso perché crediamo
in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore,
consegnato per i nostri difetti
e risuscitato per la nostra giustificazione.
– Parola del Signore.
Credere alla promessa: quando la fede diventa rettitudine
Come la convinzione di Abramo illumina il nostro rapporto con la promessa e la fiducia in Dio
Questa meditazione su Romani 4:20-25 Offre una lettura vivace e ben argomentata della fede di Abramo, un modello di fiducia che giustifica perché radicato nella promessa stessa di Dio. Paolo dispiega una teologia della fede trascendente ma incarnata: credere è già rispondere alla chiamata del Dio che compie. In un mondo in cui spesso prevale la sfiducia, questa lettera risuona come un pacifico invito a reimparare la fiducia. L'articolo è rivolto a coloro che cercano di coniugare fede, intelligenza e vita quotidiana, alla luce di una giustizia ricevuta come dono.
- Contesto: la fede di Abramo e la genealogia spirituale di Paolo.
- Analisi centrale: una fede che giustifica perché spera.
- Assi di schieramento: promessa, potere, lealtà.
- Risonanze tradizionali: dalla fede di Israele a quella della Chiesa.
- Consigli pratici: come vivere “ti sarà concesso” oggi.

Contesto
La Lettera ai Romani è probabilmente il testo più denso e teologicamente strutturato di San Paolo. Scritta intorno al 57-58, mentre si preparava al viaggio verso Gerusalemme e poi a Roma, delinea la grande architettura della giustificazione per fede. Paolo si rivolge a una comunità che non conosce ancora personalmente e cerca di unire ebrei e pagani in una comprensione condivisa della salvezza. È in questo contesto che si colloca il brano del capitolo 4, in cui Paolo evoca Abramo come figura fondante della fede.
Abramo diventa l'esempio perfetto di qualcuno che ha creduto senza prove, senza altro supporto che la parola divina. Dio gli promise una discendenza quando lui e Sara erano già avanti negli anni. Questa situazione di impossibilità mette in luce il cuore del messaggio di Paolo: la fede non nasce dalla superiorità umana, ma dalla fiducia in un Dio capace di "compiere ciò che ha promesso".
Paolo scrive: «Gli fu concesso di essere giusto». Ma, aggiunge, «la Scrittura non si occupa solo di lui»: questa affermazione ha un valore universale. Abramo non è un'icona isolata, ma la pietra angolare di un edificio spirituale che prefigura la giustificazione offerta a tutti dalla risurrezione di Cristo.
In questa prospettiva, l'espressione "ci sarà dato perché abbiamo creduto" diventa un perno teologico. Come Abramo ricevette la giustizia mediante la fede, così il credente oggi riceve la giustificazione mediante la giustificazione che egli pone in Cristo risorto. La promessa fatta ad Abramo trova il suo compimento cristiano: il passaggio dal particolare all'universale, dal carnale (discesa biologica) allo spirituale (discesa nella fede).
Questo testo, quindi, collega sottilmente tre livelli:
- il passato biblico : La fede di Abramo come modello di speranza,
- il presente paolino : la fede come principio di giustificazione,
- il presente del lettore : la fede come risposta attiva a una promessa sempre presente.
Questo intreccio consente a Paolo di proporre un'antropologia spirituale: non siamo salvati da ciò che facciamo, ma dalla fiducia viva riposta in Dio. In altre parole, la fede non è un mero assenso intellettuale, ma un atto di riconoscimento, una resa che poi si traduce in una condotta retta.
Nella cultura greco-romana, plasmata dalla logica del merito, questa idea di giustificazione gratuita e universale capovolse le consuete rappresentazioni religiose. Paolo inaugurò una nuova comprensione del rapporto tra l'uomo e Dio: non più un'ascesa morale verso il divino, ma un'alleanza in cui Dio, per primo, rende giusti coloro che accolgono la sua promessa.

Una fede che giustifica perché spera
Nel cuore di Stanza 4Paolo descrive un doppio movimento: da Dio all'uomo (la promessa) e dall'uomo a Dio (la fede). Questa dinamica di reciprocità si fonda sulla convinzione che in Dio vi sia una fedeltà assoluta. Abramo diventa testimone di una fede "contro ogni speranza": credere che qualcosa accadrà quando tutto sembra indicare il contrario.
Questo gesto interiore è performativo. Crea giustizia, non perché la produce moralmente, ma perché si adegua alla verità divina, alla promessa mantenuta. Questo è il significato stesso della parola. giustizia nella Bibbia: essere adattati, in sintonia con la volontà e la fedeltà di Dio.
Per Paolo, la giustificazione per fede non significa un'astrazione giuridica, ma un atto relazionale: diventare giusti significa sintonizzarsi sul ritmo di Dio. E questa sintonizzazione si manifesta nella storia. Abramo credette ancor prima di ricevere il segno dell'alleanza (la circoncisione), anticipando così la fede cristiana che precede le opere.
Nella seconda parte del brano, Paolo compie un salto ermeneutico decisivo: «Dicendo che questo gli è stato concesso, la Scrittura non riguarda solo lui, ma anche noi». Con questo spostamento, egli universalizza la promessa: i credenti, qualunque sia la loro origine, partecipano della stessa fede di Abramo.
Questa partecipazione si realizza pienamente in Cristo. La fede del patriarca prefigurava già quella dei discepoli che avrebbero creduto in "colui che ha risuscitato Gesù nostro Signore dai morti". Il legame tra morte e risurrezione di Cristo struttura la nuova comprensione della fede: credere è riconoscere che la vita scaturisce dalla morte, che la promessa si verifica nell'impossibile compiuto.
Di conseguenza, "ci sarà concesso" diventa la formula condensata di tutta la teologia paolina. L'atto di fede collega l'uomo al Dio vivente, non per merito, ma per consenso. Questo "ci sarà concesso" perché Dio stesso promette e realizza. La giustizia non è più uno stato da conquistare, ma una realtà da accogliere.

La promessa: un orizzonte aperto
La promessa di Dio ad Abramo – una discendenza numerosa – è intesa solo come un'apertura. Il futuro si dispiega al suo interno come uno spazio di fiducia. La fede del credente accoglie questa promessa come un orizzonte, non come un possesso. Affermando che giustizia "sarà concessa", Paolo colloca la fede nel tempo dell'attesa attiva.
Nell'esperienza umana, ogni promessa comporta un rischio: quello della delusione. Paolo capovolge questa struttura esistenziale: la promessa di Dio non tradisce mai, ma spesso si realizza in modi diversi da quelli attesi. Per questo la fede di Abramo diventa paradigmatica: non si fonda sull'attesa del compimento, ma sulla certezza del Promettente.
Credere, quindi, non è solo sperare che qualcosa accada; è già entrare nel compimento, affidandosi a Colui che parla. La promessa diventa allora dinamismo interiore, motore spirituale. Salva dalla rassegnazione.
Il potere di Dio: realizzare l'impossibile
Paolo insiste: Abramo era "pienamente convinto che Dio è capace di compiere". La fede non si basa sulla valutazione umana delle possibilità, ma sul riconoscimento di un potere creativo. Nella Bibbia, energia non significa coercizione, ma capacità di dare vita all'essere. Dio "compie" perché crea.
Questa convinzione libera Abramo dall'ansia del controllo. Gli permette di sperare senza prove. È qui che entra in gioco una dimensione essenziale della fede: l'abbandono attivo. Non è né passività né ingenuità, ma fiduciosa adesione a una forza che supera il calcolo umano.
Questo stesso atto è chiamato in Paolo pistis : una fedeltà reciproca tra Dio e l'uomo. L'energia della fede non proviene dal soggetto credente, ma dal legame tra la promessa e il suo autore. Così, "ciò che egli promette, lo compie" diventa non uno slogan morale, ma una descrizione della realtà così come Dio la plasma.
Fedeltà: fede e giustificazione
Nella logica paolina, essere giustificato significa essere messi in una giusta relazione. Abramo non è dichiarato giusto perché compie opere esemplari, ma perché la sua fiducia apre il suo cuore alla fedeltà divina. La giustizia diventa una risposta. Credendo, l'uomo lascia che Dio sia Dio.
Il legame tra fede e fedeltà è inscindibile: credere è accogliere la fedeltà del Dio che crede nell'uomo. Questa circolarità è il fondamento della giustificazione. Nella risurrezione di Cristo, essa raggiunge la sua pienezza: risuscitando Gesù, Dio autentica non solo il suo Messia, ma anche la promessa fatta ad Abramo. D'ora in poi, la fede umana si fonda su un evento sigillato nella storia.
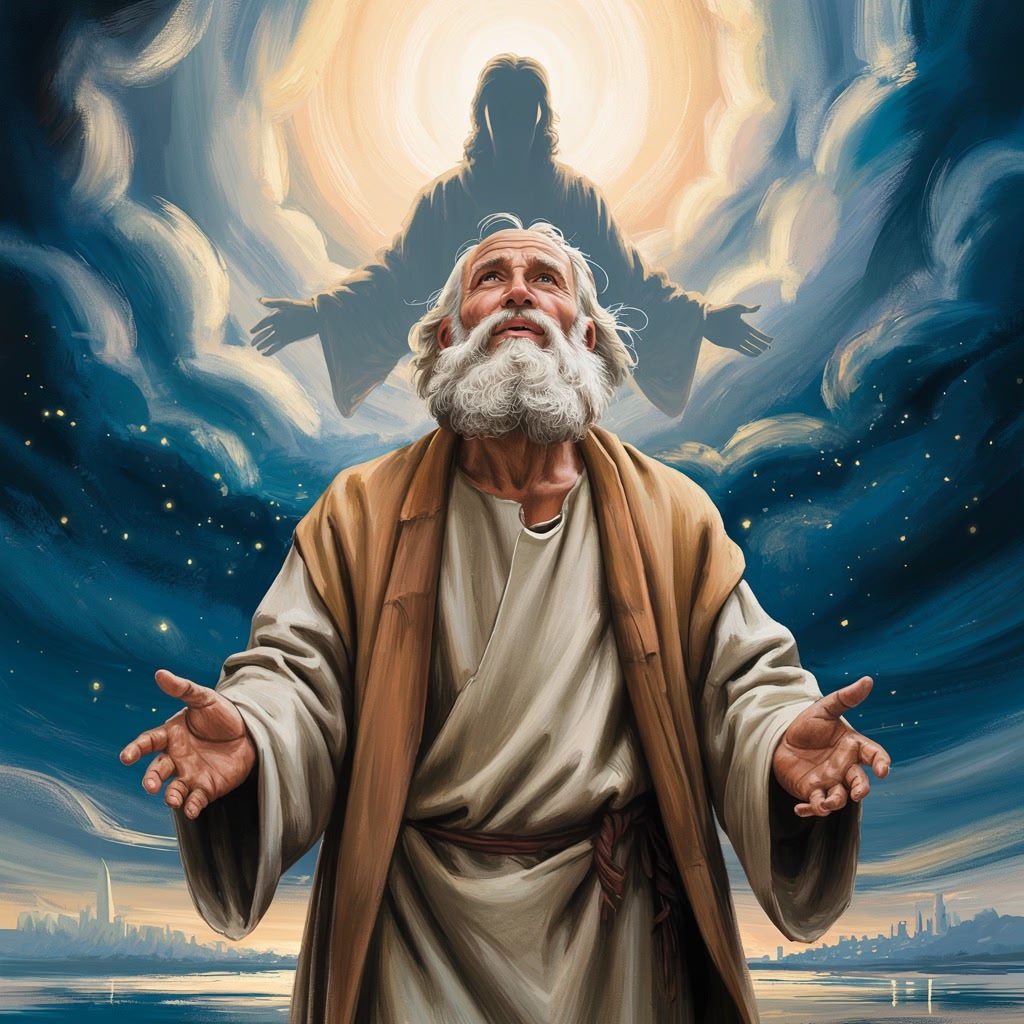
Risonanze
L'interpretazione di Paolo amplia quella già iniziata nella tradizione ebraica. Genesi 15Abramo viene dichiarato giusto prima di vedere la promessa compiuta. I Padri della Chiesa, in particolare Ireneo e Agostino, leggeranno questo brano come fondamento della teologia della grazia. Per Agostino, la fede di Abramo annuncia la giustificazione "senza le opere della Legge", perché Dio "rende giusto il peccatore" attraverso l'amore.
Nel Medioevo, Tommaso d'Aquino avrebbe ripreso lo stesso tema nella Summa Theologica : la giustizia non è il frutto delle nostre azioni, ma della partecipazione alla verità divina. Lutero avrebbe poi riscoperto questa affermazione paolina e ne avrebbe fatto il fondamento della Riforma. Così, di secolo in secolo, il testo alimenta diverse concezioni della fede attiva.
Nella spiritualità contemporanea, questa promessa "sarà concesso" è intesa anche come una chiamata concreta: Dio continua a scrivere con noi promesse di liberazione. Credere diventa allora un atto di resistenza alla paura e al cinismo.
Meditazioni
- Rileggi la promessa personale : Quali parole di fede mi sono state date? Scrivile e affidale alla preghiera.
- Dare un nome all'impossibile : Identificare le aree in cui non credo più nella possibilità che Dio agisca.
- Pratica la gratitudine : Ogni sera, ringrazia per una promessa già mantenuta.
- Cerca la vestibilità : In un conflitto, in una scelta, mi chiedo: qual è la fedeltà alla quale Dio mi chiama qui?
- Speranza per gli altri : Intercedi per coloro che dubitano, come Abramo per i suoi discendenti.
La fede come spazio comune
Concludendo questa lettura, possiamo comprendere la confessione di Paolo non come un trattato teologico, ma come un invito personale. Abramo credette, e questa fede è giunta fino a noi attraverso i secoli. Credere oggi significa inscrivere la propria esistenza in una linea di speranza.
Quando tutto in noi esige la garanzia del visibile, la fede offre un altro sostegno: la promessa di un Dio che compie. Questa promessa ci invita all'apertura, alla pazienza, allo stupore. Rende la vita di fede un'avventura condivisa: non il possesso della verità, ma il camminare con Colui che mantiene la sua parola.
COSÌ, "ci sarà concesso" diventa più di un'affermazione dogmatica: un respiro del cuore credente. È il linguaggio della fiducia offerta, la grammatica della gioia, la certezza che la giustizia non è dovuta, ma un dono.
Pratico
- Medita ogni mattina su una frase di una promessa biblica.
- Annota i segnali di fedeltà riscontrati durante la settimana.
- Sostituisci una lamentela con una parola di fiducia.
- Leggere Genesi 15 E Stanza 4 in parallelo.
- Prega per credere “contro ogni speranza”.
- Affida la tua giornata: “Dio, fai ciò che prometti”.
- Trasmettere la pace ricevuta a una persona nel dubbio.
Riferimenti
- La Bibbia di Gerusalemme, Lettera ai Romani.
- Agostino, Di fede e di opere.
- Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, II-II.
- Lutero, Commento alla Lettera ai Romani.
- J. Guitton, Fede e ragione.
- Benedetto XVI, Spe Salvi.
- N. Lohfink, Teologia della promessa nell'Antico Testamento.



