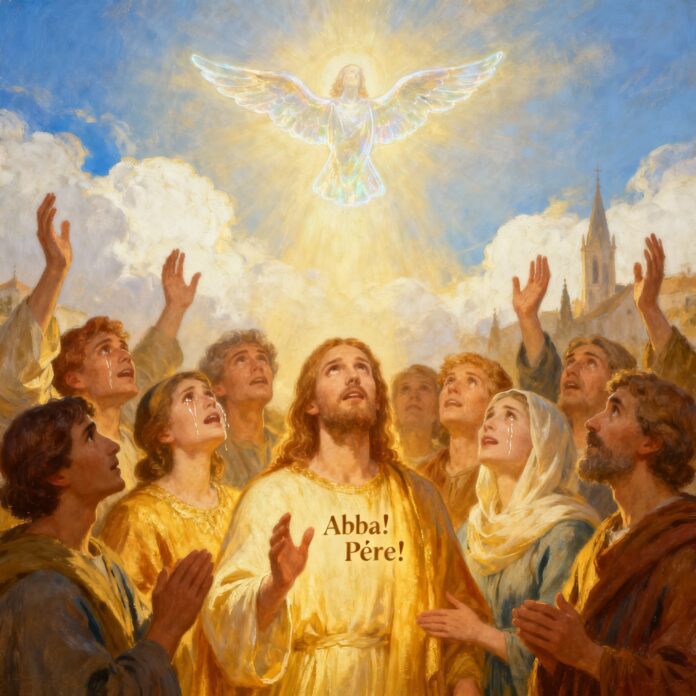Lettura della lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli,
abbiamo un debito,
ma non è verso la carne
dover vivere secondo la carne.
Perché se vivete secondo la carne,
morirai;
ma se, per mezzo dello Spirito,
tu uccidi le azioni dell'uomo peccatore,
vivrai.
Per tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio,
Questi sono i figli di Dio.
Non avete ricevuto uno spirito che vi rende schiavi
e ti riporta alla paura;
ma avete ricevuto uno Spirito che vi ha resi figli;
ed è in lui che gridiamo " Abba! ", cioè: Padre!
Quindi è lo Spirito Santo stesso che rende testimonianza al nostro spirito
che siamo figli di Dio.
Poiché siamo suoi figli,
siamo anche i suoi eredi:
eredi di Dio,
eredi con Cristo,
se almeno soffriamo con lui
per essere con lui nella gloria.
– Parola del Signore.
Dalla schiavitù alla figliolanza: come lo Spirito Santo trasforma la nostra identità
Scopri perché Paolo chiama Dio “Abba” e cosa questo cambia radicalmente nella tua vita spirituale.
Nella sua lettera ai Romani, Paolo propone una rivoluzione spirituale: non siamo più schiavi tremanti davanti a un padrone distante, ma figli adottati da Dio stesso. Questa trasformazione radicale è operata dallo Spirito Santo, che ci permette di gridare "Abbà!" – la parola intima che Gesù usava per rivolgersi al Padre. Questo brano capovolge la nostra comprensione della vita cristiana: vivere secondo lo Spirito non è un vincolo morale, ma l'apprendimento di una libertà filiale che ci conduce verso la gloria promessa.
Esploreremo innanzitutto il contesto storico e teologico di questa affermazione paolina, per poi analizzare la dinamica centrale del testo: il passaggio dalla paura alla fiducia. Approfondiremo poi tre dimensioni essenziali: la libertà donata dallo Spirito, la ritrovata intimità con Dio e la gloriosa eredità promessa ai figli. Infine, scopriremo come mettere in pratica questa figliolanza divina nella nostra vita quotidiana.

Contesto: Paolo scrive ai cristiani di Roma
Quando Paolo scrisse la sua lettera ai Romani, probabilmente intorno al 57-58 d.C. da Corinto, si rivolgeva a una comunità che non aveva ancora visitato personalmente. Roma, capitale dell'Impero, ospitava una comunità cristiana eterogenea, composta da convertiti di origine sia ebraica che pagana. Paolo, l'apostolo delle genti, cercò di stabilire i fondamenti teologici della fede cristiana con una profondità e una sistematicità senza pari nei suoi altri scritti.
Il capitolo 8 della Lettera ai Romani costituisce uno dei vertici del pensiero paolino. Dopo aver ampiamente sviluppato la giustificazione per fede e la liberazione dal peccato, Paolo affronta ora la vita nello Spirito. Questo brano si presenta come una risposta concreta alla domanda esistenziale che ogni credente si pone: come possiamo vivere quotidianamente questa nuova realtà spirituale?
Il vocabolario utilizzato da Paolo rivela un'intenzione specifica. Utilizza il termine greco "huiothesia", che si riferiva all'adozione legale nel mondo romano. Questa nozione aveva un notevole significato giuridico: il bambino adottato diventava un erede a pieno titolo, proprio come un figlio biologico. Paolo attinge quindi al vocabolario sociale del suo tempo per esprimere una realtà spirituale rivoluzionaria.
L'opposizione tra "carne" e "Spirito" struttura l'intero brano. Nel linguaggio paolino, la carne non designa semplicemente il corpo fisico, ma l'intera esistenza umana orientata verso se stessa, separata da Dio, imprigionata dai propri limiti. Lo Spirito, al contrario, rappresenta la potenza divina che viene ad abitare il credente e a trasformarlo dall'interno.
La parola aramaica "Abba" occupa un posto centrale. Gesù la usava per rivolgersi a Dio, e i Vangeli hanno conservato questo termine nella sua lingua originale, a testimonianza della sua importanza. "Abba" unisce la tenerezza infantile al rispetto filiale. Non è né il semplice "papà" che a volte viene tradotto, né il distante e formale "padre", ma un'espressione di intimità fiduciosa.
Nel contesto liturgico, questo brano viene spesso proclamato durante le feste che celebrano lo Spirito Santo, in particolare la Pentecoste o la Trinità. Ci ricorda che la vita cristiana non si riduce a seguire un codice morale esteriore, ma consiste nel vivere una relazione filiale con Dio attraverso lo Spirito. Questa prospettiva cambia radicalmente il nostro approccio alla preghiera, all'etica e alla speranza cristiana.
Analisi: La dinamica della trasformazione interiore
Paolo struttura la sua argomentazione attorno a un contrasto sorprendente: due modi di esistere si contrappongono, uno che conduce alla morte, l'altro alla vita. Questa opposizione non è semplicemente morale o comportamentale; tocca l'identità stessa del credente.
La prima parte del testo pone un debito paradossale: abbiamo un debito, ma non verso la carne. Questa sorprendente formulazione capovolge la logica consueta. Nell'esperienza umana ordinaria, è proprio ai nostri desideri, alle nostre paure, ai nostri istinti che sembriamo dover qualcosa. Paolo afferma il contrario: non dobbiamo nulla a questa logica di morte. La liberazione operata da Cristo ci ha liberati da ogni obbligo di peccato.
Il verbo "uccidere" usato da Paolo per parlare delle azioni dell'uomo peccatore rivela la natura radicale del combattimento spirituale. Non si tratta di migliorare gradualmente il nostro comportamento, ma di mettere a morte ciò che appartiene al vecchio regime. Questa violenza spirituale è possibile solo "per mezzo dello Spirito", specifica Paolo. L'ascesi cristiana non è mai uno sforzo puramente umano, ma una cooperazione con la potenza divina che opera in noi.
La svolta decisiva del brano avviene con l'affermazione della figliolanza: "Non avete ricevuto uno spirito da schiavi". Qui Paolo individua il cuore del problema umano: la paura. L'umanità vive naturalmente nella paura davanti a Dio, paura del giudizio, della punizione, dell'abbandono. Questa paura genera la schiavitù interiore, la servitù psicologica che paralizza l'esistenza.
Lo Spirito ricevuto produce l'effetto opposto: genera la libertà filiale. Questa libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma nel vivere nella fiducia, senza il terrore che caratterizza lo schiavo. Il bambino a volte sbaglia, persino disobbedisce, ma sa che rimane bambino, che la sua identità non dipende dalle sue prestazioni.
Il grido "Abbà! Padre!" è il culmine di questa trasformazione. Paolo usa il verbo "crazo", che evoca un grido potente e spontaneo dal profondo. Non è una recitazione cortese, ma un'espressione sgorgante di riconoscimento interiore. Lo Spirito stesso pronuncia questo grido attraverso di noi, testimoniando al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio.
Questa attestazione interiore merita attenzione. Paolo non si riferisce a una conoscenza teorica o a una dottrina intellettualmente accettata. Lo Spirito attesta, cioè produce una certezza esistenziale, una convinzione profonda che trasforma la nostra percezione di noi stessi e di Dio. Questa certezza non è orgogliosa, ma pacifica; ci libera dall'ansia spirituale.

La libertà donata dallo Spirito: andare oltre la logica della performance
La prima dimensione che dobbiamo esplorare riguarda la natura stessa di questa libertà spirituale annunciata da Paolo. Troppo spesso riduciamo la vita cristiana a un elenco di comandamenti da osservare, pratiche da compiere e peccati da evitare. Questo approccio, pur contenendo una parte di verità, trascura l'essenziale messaggio paolino.
Vivere "secondo la carne", nel vocabolario di Paolo, significa organizzare la propria esistenza attorno alle proprie risorse, alle proprie capacità naturali, alla propria volontà personale. Questa logica porta paradossalmente al fallimento e alla morte, non perché lo sforzo umano sia intrinsecamente cattivo, ma perché non può realizzare la trasformazione interiore che solo Dio può operare. L'uomo abbandonato a se stesso gira in tondo, ripete gli stessi schemi e rimane prigioniero dei propri limiti.
Lo Spirito introduce una dinamica radicalmente diversa. Non si limita ad assistere i nostri sforzi o a rafforzare la nostra volontà. Produce in noi ciò che non possiamo produrre da soli: la vita divina, la somiglianza a Cristo, la capacità di amare come ama Dio. Questa azione dello Spirito non ci toglie la responsabilità, ma la colloca in un contesto diverso: collaboriamo con una grazia che ci precede e ci accompagna.
La metafora dell'uccisione delle azioni dell'uomo peccatore rivela un aspetto spesso trascurato della spiritualità cristiana. Non è una guerra contro noi stessi che porta all'odio per la nostra umanità. Il nemico non sono i nostri corpi, le nostre emozioni o i nostri desideri, ma le dinamiche distorte dal peccato: l'orgoglio che ci isola, l'egoismo che ci chiude in noi stessi, la gelosia che ci avvelena, la paura che ci paralizza.
Questa uccisione è compiuta "dallo Spirito", specifica Paolo. Non siamo abbandonati alle nostre forze in questa lotta. Lo Spirito agisce come una forza trasformatrice che modifica gradualmente i nostri desideri più profondi, rinnova le nostre motivazioni e purifica le nostre intenzioni. Questa azione divina rispetta i nostri ritmi e i nostri limiti; non ci violenta, ma ci libera a poco a poco.
La libertà filiale è fondamentalmente diversa dalla licenza. Non è il permesso di fare ciò che si desidera, ma la riscoperta capacità di scegliere il bene per amore e non per costrizione. Il figlio obbedisce in modo diverso dallo schiavo: non per paura della punizione, ma per fiducia nella saggezza del padre, per desiderio di assomigliargli, per gratitudine per il suo amore.
Questa libertà si sperimenta concretamente nella vita morale quotidiana. Di fronte alla tentazione, il cristiano animato dallo Spirito non si limita a resistere con la volontà. Scopre un desiderio più profondo, quello della comunione con Dio, che ridimensiona l'attrattiva del peccato. La lotta spirituale diventa meno una feroce lotta contro se stessi, che un progressivo orientamento verso un bene più grande che attrae e libera.
Intimità ritrovata con Dio: riscoprire la preghiera filiale
La seconda dimensione essenziale del nostro testo riguarda la relazione stessa con Dio. Il passaggio dalla schiavitù alla figliolanza cambia radicalmente il nostro modo di pregare, di considerare Dio e di vivere quotidianamente la nostra fede.
Lo spirito di schiavitù evocato da Paolo produce una religione di paura. Dio diventa un giudice severo, un sorvegliante spietato, un contabile che registra ogni colpa. Questa immagine di Dio, sebbene contenga una certa verità sulla giustizia divina, distorce la rivelazione cristiana. Genera una spiritualità ansiosa, ossessionata dalla perfezione, incapace di pace interiore.
Il timore religioso paralizza la preghiera. Lo schiavo si avvicina al padrone tremando, calcola le parole, attende il verdetto. La sua preghiera diventa formale, recitativa, distante. Recita formule dotte, esegue riti prescritti, ma non incontra veramente Dio. Il cuore rimane chiuso, protetto da osservanze esteriori.
Lo Spirito di adozione trasforma questa dinamica. Egli produce in noi la capacità di dire "Abbà", la parola che solo Gesù ha pronunciato con tanta fiduciosa semplicità. Non ci appropriamo di un titolo che ci è estraneo, ma lo Spirito ci rende partecipi della relazione stessa che il Figlio ha con il Padre. È Lui che grida in noi, attraverso di noi, attraverso di noi.
Questa preghiera filiale è caratterizzata dalla spontaneità. Il grido "Abbà" non è una formula liturgica sapientemente composta, ma l'espressione immediata di una gratitudine interiore. Scaturisce dal cuore senza calcoli, senza elaborata preparazione. Il bambino non ci pensa a lungo prima di chiamare il padre; lo fa naturalmente, nel bisogno come nella gioia.
L'intimità con Dio non significa mancanza di rispetto o familiarità fuori luogo. La parola "Abba" in lingua aramaica combina tenerezza e rispetto. Il bambino onora il padre proprio perché lo conosce e lo ama. Questa conoscenza personale stabilisce una vera riverenza, ben diversa dal timore servile.
La preghiera cristiana diventa un dialogo vivo. Non parliamo più a un Dio lontano che forse ci ascolta, ma al Padre che ci ascolta attentamente, che si prende cura di noi, che interviene nella nostra esistenza. Questa certezza trasforma il nostro modo di pregare: osiamo chiedere, accettiamo di lamentarci, condividiamo le nostre gioie, presentiamo i nostri bisogni reali e non richieste pie e artificiali.
La testimonianza interiore menzionata da Paolo diventa un'esperienza spirituale concreta. Nella preghiera filiale, a volte percepiamo la presenza dello Spirito che rende testimonianza al nostro spirito. Non è necessariamente un'esperienza straordinaria o mistica, ma una pace profonda, una dolce certezza, una fiducia che si insinua nonostante le circostanze difficili. Sappiamo di essere ascoltati, di non essere soli, che il Padre veglia sui suoi figli.

L'eredità promessa: vivere già nella prospettiva della gloria
La terza dimensione del nostro testo si apre al futuro e dà alla nostra esistenza presente la sua direzione ultima. Paolo non si limita ad affermare la nostra filiazione presente, ma ne trae le conseguenze escatologiche: siamo eredi, chiamati a condividere la gloria di Cristo.
Il vocabolario dell'eredità aveva un significato concreto nel mondo romano. L'erede riceveva non solo i beni materiali del defunto, ma anche il suo nome, il suo status sociale, il suo posto nella società. Paolo traspone questa realtà giuridica sul piano spirituale: ereditiamo Dio stesso, la sua natura, la sua vita, la sua gloria.
Questa prospettiva di eredità trasforma la nostra comprensione dell'esistenza cristiana. Non viviamo semplicemente per migliorare il presente o osservare i comandamenti, ma per prepararci a ricevere una pienezza che supera ogni immaginazione. Questa speranza non è una fuga dal mondo reale, ma una forza che dà significato e coraggio di fronte alle difficoltà attuali.
Paolo, tuttavia, introduce una condizione che può sorprendere: «se davvero soffriamo con lui». Questa precisazione non mette in discussione la gratuità dell'adozione, ma sottolinea che la conformazione a Cristo passa necessariamente attraverso la croce prima della risurrezione. L'erede condivide il destino di colui che eredita: se Cristo ha sofferto, soffriremo anche noi.
Questa sofferenza "con Cristo" non si riferisce a una qualsiasi difficoltà dell'esistenza. Paolo parla di una condivisione volontaria del destino di Cristo, di un'accettazione delle prove legate alla testimonianza cristiana, di una solidarietà con il Crocifisso nella nostra stessa carne. Questa prospettiva dà senso alle inevitabili sofferenze della vita e trasforma il nostro modo di viverle.
La speranza della gloria non ci proietta in un futuro lontano e astratto. Influenza il nostro presente, mettendo in prospettiva le difficoltà attuali. Come scriverà Paolo subito dopo il nostro brano, le sofferenze del tempo presente non sono nulla in confronto alla gloria che sarà rivelata. Questo paragone non minimizza la realtà della sofferenza, ma la colloca in una prospettiva più ampia.
La glorificazione promessa riguarda tutto il nostro essere. Paolo non parla di una sopravvivenza disincarnata dell'anima, ma di una completa trasformazione della nostra persona, incluso il corpo. La risurrezione di Cristo prefigura la nostra risurrezione. Siamo chiamati a condividere non solo la sua vita spirituale, ma anche la sua gloria corporea, in un mondo rinnovato.
Questa speranza dà impulso alla nostra vita morale e spirituale. Non ci rassegniamo alla mediocrità presente, ma ci alleniamo fin da ora a vivere come figli di Dio, per manifestare le primizie della gloria futura. Le virtù cristiane diventano l'apprendistato di un'esistenza gloriosa, la preparazione a una vita pienamente riconciliata con Dio e con il creato.
Tradizione: come la Chiesa ha meditato questo testo
Questo passo della Lettera ai Romani ha profondamente influenzato la spiritualità cristiana nel corso dei secoli. I Padri della Chiesa vi hanno riconosciuto uno dei fondamenti della loro teologia della divinizzazione, la dottrina secondo cui l'uomo è chiamato a partecipare della natura divina.
Sant'Agostino, nei suoi commenti alla Lettera ai Romani, sottolinea il ruolo dello Spirito nel farci gridare "Abbà". Sottolinea che questa preghiera non proviene dalle nostre forze, ma dalla grazia divina che opera in noi. Agostino vede in questo grido filiale la prova della nostra trasformazione interiore: non pretendiamo di essere figli di Dio, lo siamo veramente per l'azione dello Spirito.
San Tommaso d'Aquino, nella sua Summa Theologica, sviluppa il concetto di adozione divina, attingendo ampiamente a questo testo paolino. Egli spiega che l'adozione umana non cambia la natura del figlio adottivo, mentre l'adozione divina ci trasforma veramente, rendendoci partecipi della natura divina. Questa distinzione ci aiuta a comprendere la natura radicale della filiazione cristiana: non siamo semplicemente figli dichiarati, ma lo diventiamo realmente.
La spiritualità benedettina ha particolarmente apprezzato la preghiera "Abbà", considerandola l'espressione più pura dell'umiltà filiale. Nella Regola di San Benedetto, la preghiera del monaco deve essere breve e pura, sgorgare dal cuore piuttosto che moltiplicare le parole. Il grido "Abbà" incarna perfettamente questo ideale di preghiera semplice e fiduciosa.
La liturgia della Chiesa ha integrato questo tema della filiazione in diversi momenti chiave. La preghiera del Padre Nostro, prima della Comunione, è preceduta da un'introduzione che ripete esplicitamente questo brano: "Come abbiamo imparato dal Salvatore e secondo il suo comando, osiamo dire: Padre nostro...". Questo verbo "osare" ci ricorda che possiamo chiamare Dio "Padre" solo per grazia di adozione.
I mistici cristiani trovarono in questo testo una conferma delle loro più profonde esperienze spirituali. Teresa d'Avila descrive come, nella preghiera profonda, l'anima si senta veramente figlia di Dio, con una certezza che supera ogni ragionamento intellettuale. Giovanni della Croce evoca questa azione dello Spirito che prega in noi e ci rende partecipi della vita trinitaria.
La teologia contemporanea continua a esplorare la ricchezza di questo brano. La riflessione sulla Trinità economica, quella rivelata nella storia della salvezza, si fonda su questa azione dello Spirito che ci fa gridare "Abbà". Entriamo così nel mistero delle relazioni trinitarie, non attraverso speculazioni astratte, ma attraverso un'esperienza spirituale concreta.

Meditazione: vivere la filiazione quotidianamente
Per incarnare nella nostra vita ordinaria questa realtà della filiazione divina, ecco un percorso progressivo in sette tappe, ciascuna delle quali illumina una dimensione pratica della nostra relazione filiale con Dio.
Inizia la giornata come figlio di DioAppena svegli, prima di controllare i messaggi o pianificare le nostre attività, prendiamoci un momento per ricordare la nostra vera identità. Sussurriamo semplicemente "Abba, Padre" e lasciamo che questa parola penetri in noi. Questa pratica riporta immediatamente la nostra consapevolezza su ciò che conta di più: siamo amati prima di agire.
Pregare con spontaneitàDurante la giornata, osiamo parlare a Dio come a un padre, senza formule complicate. Condividiamo con lui le nostre preoccupazioni reali, le nostre gioie semplici, i nostri interrogativi, i nostri bisogni. Questa preghiera spontanea sviluppa l'intimità e scioglie i blocchi della preghiera formale.
Discernere i movimenti dello SpiritoImpariamo a riconoscere le ispirazioni interiori che ci guidano verso il bene, la pace e la carità. Lo Spirito ci guida gradualmente se prestiamo attenzione a questi movimenti discreti. Un diario spirituale può aiutarci a identificare queste azioni divine nella nostra vita quotidiana.
Accettare le correzioni paterneUn padre amorevole educa i suoi figli. Invece di ribellarci alle difficoltà o ai fallimenti, cerchiamo ciò che Dio vuole insegnarci. Questo atteggiamento trasforma le prove in opportunità di crescita spirituale.
Coltivare la fiducia nei momenti difficiliQuando l'ansia aumenta o le circostanze ci sopraffanno, ripetiamo a noi stessi: "Abbà, Padre, tu vegli su di me". Questa semplice preghiera combatte la paura e ripristina la pace interiore. Sposta la nostra attenzione dai nostri problemi alla cura di Dio.
Vivere come eredi del RegnoLe nostre scelte quotidiane, anche le più piccole, preparano il nostro ingresso nella gloria. Scegliere la generosità anziché l'egoismo, la verità anziché la menzogna, il servizio anziché il dominio: queste decisioni ci configurano gradualmente a Cristo e ci preparano all'eredità promessa.
Meditare regolarmente sulla nostra dignità filialePrendiamoci del tempo ogni settimana per meditare sul testo di Paolo. Lasciamo che le parole "voi siete figli di Dio, eredi di Cristo" risuonino dentro di noi. Questa contemplazione trasforma gradualmente la nostra immagine di noi stessi e il nostro rapporto con Dio.
Conclusione: l'audacia della filiazione
Il brano della Lettera ai Romani che abbiamo esplorato rivela una rivoluzione spirituale di cui forse non comprendiamo ancora appieno le conseguenze. Paolo non propone semplicemente un cambiamento nella nostra vita religiosa, ma una trasformazione completa della nostra identità. Non siamo più schiavi ansiosi che cercano di compiacere un padrone capriccioso, ma figli fiduciosi accolti da un Padre amorevole.
Questa filiazione divina non è una pia metafora o una consolazione sentimentale. Costituisce la realtà più profonda della nostra esistenza cristiana. Lo Spirito Santo stesso dimora in noi e testimonia al nostro spirito che apparteniamo alla famiglia di Dio. Questa certezza interiore, se vissuta autenticamente, trasforma il modo in cui preghiamo, lottiamo contro il peccato, affrontiamo le prove e speriamo nella gloria futura.
Il cammino proposto da Paolo, tuttavia, richiede il nostro consenso attivo. Lo Spirito non ci trasforma nostro malgrado, come per magia. Si aspetta la nostra cooperazione, la nostra docilità, la nostra apertura alla sua azione. Uccidere le azioni dell'uomo peccatore "per mezzo dello Spirito" significa collaborare con la grazia divina, accogliere la sua opera purificatrice, accettare le sfide che essa comporta.
L'invito è radicale: osiamo vivere come figli di Dio, non solo nei momenti di preghiera, ma in tutte le dimensioni della nostra esistenza. Questa audacia filiale trasformerà le nostre relazioni umane, i nostri impegni professionali, le nostre scelte etiche, il nostro modo di abitare il mondo. Diventeremo testimoni viventi della tenerezza paterna di Dio, dimostrando attraverso la nostra gioiosa libertà che il Vangelo non è un peso ma una liberazione.
L'eredità promessa ci attende. La gloria che condivideremo con Cristo supera qualsiasi cosa possiamo immaginare. Ma questa speranza non è una scusa per fuggire dal presente. Al contrario, ci coinvolge nell'oggi di Dio, ci spinge a vivere ora come eredi del Regno, a manifestare nella nostra vita concreta le primizie di una creazione rinnovata.
Che il grido “Abbà, Padre!” diventi il respiro della nostra anima, l’espressione spontanea del nostro cuore trasformato dallo Spirito. È in questa semplicità filiale che si dispiega la vera sapienza cristiana, quella che ci configura a Cristo e ci prepara alla comunione eterna con Dio.
Pratico
Preghiera del mattino : Inizia ogni giorno sussurrando “Abba, Padre” prima di qualsiasi altra attività, per ancorare la tua identità alla figliolanza divina.
Esame di coscienza filiale : Ogni sera chiediti se hai vissuto come figlio di Dio o come schiavo della paura e delle costrizioni.
Pratica della fiducia : Nei momenti di ansia, ripeti a te stesso: "Mio Padre veglia su di me", per combattere lo spirito di paura servile.
Lettura meditativa : Rileggi Romani 8 ogni settimana, annotando su un quaderno i movimenti interiori suscitati da questo testo.
Preghiera spontanea : Parla con Dio durante tutto il giorno con la semplicità di un bambino che parla con suo padre, senza formule complicate.
Discernimento quotidiano : Identifica un'ispirazione dello Spirito ricevuta durante la giornata e nota come hai reagito o come ti sei opposto ad essa.
Orientamento all'eredità : Ogni decisione morale importante, per quanto piccola, considerala come una preparazione per il tuo ingresso nella gloria promessa.
Riferimenti
Lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 8, versetti 12-17, testo principale di questa meditazione sulla filiazione divina e l'azione dello Spirito Santo.
Sant'Agostino, Commentari sulla Lettera ai Romani, analisi patristica della grazia divina e dell'adozione filiale nel pensiero paolino.
San Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, IIa-IIae, domanda 45 sui doni dello Spirito Santo e sulla natura dell'adozione divina che trasforma veramente il credente.
Teresa d'Avila, Il Castello Interiore, un'esplorazione mistica dell'intimità con Dio e dell'esperienza della figliolanza divina nella preghiera profonda.
Giovanni della Croce, La salita del Carmelo, riflessione sull'unione con Dio e sull'azione dello Spirito che ci fa partecipare alla vita trinitaria.
Catechismo della Chiesa Cattolica, paragrafi 1996-2005 sulla giustificazione e 2777-2785 sulla preghiera del Padre Nostro come espressione di fiducia filiale.
Romano Guardini, Il Signore, meditazioni sulla preghiera di Gesù e sul significato della parola “Abba” nella rivelazione cristiana.
Hans Urs von Balthasar, La teologia della storia, sviluppo teologico sull'adozione filiale e la partecipazione alla vita trinitaria mediante lo Spirito Santo.