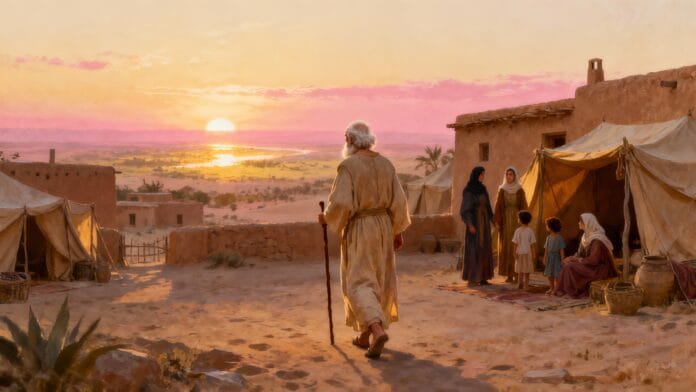Lettura dal libro della Genesi
In quei giorni,
Il Signore disse ad Abramo:
“Lascia il tuo paese,
i tuoi parenti e la casa di tuo padre,
e andate nel paese che io vi mostrerò.
Farò di te una grande nazione,
Ti benedirò,
Renderò grande il tuo nome,
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno;
Chiunque ti maledirà, io lo condannerò.
In te sarà benedetto
tutte le famiglie della terra."
Abramo partì, come gli aveva detto il Signore,
e Lot andò con lui.
– Parola del Signore.
Partire per rinascere: la chiamata di Abramo e la rivoluzione interiore
Quando Dio capovolge le nostre certezze per offrirci l'impossibile, la fede diventa l'unica via verso una nuova vita..
La chiamata di Abramo in Genesi 12,1-2 rappresenta molto più di un lontano episodio storico: inaugura un modo radicalmente nuovo di esistere davanti a Dio e con gli altri. A quest'uomo di settantacinque anni viene ordinato di lasciare tutto – patria, famiglia, casa paterna – per incamminarsi verso un orizzonte sconosciuto, guidato solo da una promessa divina. Questa rottura fondante rivela la dinamica profonda di ogni autentica vita spirituale: accettare la perdita dei propri punti di riferimento per ricevere infinitamente di più di ciò che si abbandona. Abramo diventa così il prototipo del credente, colui che si fida di una Parola prima di vederne il compimento.
Esploreremo innanzitutto il contesto storico e teologico di questa chiamata fondativa, per poi analizzare le dinamiche paradossali della fede obbediente. Approfondiremo poi tre dimensioni essenziali: lo sradicamento come condizione di benedizione, la promessa come forza motrice dell'esistenza e la vocazione universale inscritta nell'elezione particolare. Infine, scopriremo come la tradizione spirituale e la vita pratica possano incarnare oggi questa audacia abramitica.

Il contesto biblico: quando Dio rompe il silenzio
Una svolta nella storia della salvezza
La chiamata di Abramo giunge in un momento cruciale della storia biblica. Dopo i primi undici capitoli della Genesi, che raccontano la creazione, la caduta, il diluvio e la dispersione dei popoli a Babele, la narrazione cambia radicalmente prospettiva. Fino ad allora, Dio era intervenuto universalmente, rivolgendosi a tutta l'umanità o punendone gli eccessi collettivi. Con Abramo, il Signore adotta una nuova strategia: scegliere un uomo particolare, un popolo specifico, per unirsi a tutti i popoli. Questa elezione singolare non è un privilegio esclusivo, ma un servizio universale. La Torre di Babele aveva portato alla confusione delle lingue e alla frammentazione dell'umanità; la chiamata di Abramo apre la via opposta, quella della progressiva riconciliazione di tutti i popoli attorno a una benedizione comune.
Il testo biblico non ci dice quasi nulla di Abramo prima di questa chiamata. Sappiamo solo che visse a Ur dei Caldei, una civiltà avanzata della Mesopotamia dove regnavano il politeismo e l'astrologia. La tradizione ebraica racconterà più tardi che Abramo scoprì l'unico Dio attraverso la propria riflessione, rifiutando gli idoli della sua famiglia. Ma il testo canonico rimane sobrio: è Dio che prende l'iniziativa, che rompe il silenzio, che irrompe in un'esistenza ordinaria per trasformarla in un destino straordinario. Questa discrezione narrativa sottolinea un principio essenziale: la fede non nasce principalmente da una ricerca umana, ma da una chiamata divina. Non è Abramo che trova Dio; è Dio che lo trova e lo rivela a se stesso.
Il contenuto della chiamata: partenza e ricezione
L'ordine divino implica due movimenti apparentemente contraddittori, ma profondamente interconnessi. Innanzitutto, una rottura: "Lascia la tua patria, la tua famiglia e la casa di tuo padre". Questa triplice separazione – geografica, di clan e familiare – rappresenta uno strappo totale dalle appartenenze naturali che definivano l'identità di un uomo nell'antichità. Abramo non deve semplicemente spostarsi o viaggiare; deve accettare di diventare uno straniero, perdere le radici che lo nutrivano e rinunciare alle eredità che lo proteggevano. È un lutto anticipato di tutto ciò che costituiva la sua sicurezza umana.
Ma questa rottura non è fine a se stessa: apre subito a una promessa sovrabbondante. «Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione». La logica divina sfida ogni razionalità: è perdendo il suo clan che Abramo diventerà padre di una moltitudine; è lasciando la sua casa che riceverà una patria; è diventando straniero che sarà fonte di benedizione universale. Dio non chiede un sacrificio sterile, ma una fruttuosa espropriazione. Non cerca di impoverire Abramo, ma di liberarlo dai suoi limiti per offrirgli l'illimitato.
La destinazione rimane volutamente vaga: «verso la terra che io ti indicherò». Abramo non riceve alcuna mappa, alcun itinerario preciso, alcuna garanzia tangibile. Deve partire senza sapere dove sta andando, come ci ricorderà la Lettera agli Ebrei. Questa indeterminatezza non è crudeltà divina, ma pedagogia spirituale: obbliga Abramo a vivere in pura fiducia, a rinnovare ogni giorno il suo atto di fede, a non adagiarsi su certezze acquisite. La fede autentica non richiede prima prove, ma confida in una Persona. Non si affida a sicurezze visibili, ma a una Parola invisibile.
La risposta immediata: obbedire senza negoziare
Il resto del racconto biblico colpisce per la sua sobrietà: "Abramo partì, come il Signore gli aveva ordinato". Nessuna discussione, nessuna obiezione, nessuna negoziazione. A differenza di altre figure bibliche come Mosè o Geremia, che avrebbero discusso a lungo con Dio per sottrarsi alla loro missione, Abramo risponde con un'obbedienza immediata. Questa prontezza non significa che non abbia sentito la violenza di essere strappato via o l'angoscia dell'ignoto. Piuttosto, rivela la profondità della sua fiducia: qualcosa nella Parola di Dio toccò il suo cuore così profondamente che preferì l'incertezza con Dio alla sicurezza senza di Lui.
Questa obbedienza inaugurale diventa il modello per tutta la vita di Abramo. Più volte, dovrà ripetere questa partenza: lasciare Haran, scendere in Egitto durante la carestia, accettare la separazione da Lot, circoncidere la propria carne all'età di novantanove anni e infine essere pronto a sacrificare Isacco sul monte Moria. Ogni episodio riproduce la struttura fondamentale di Genesi 12: un comando divino che travolge, una fede che obbedisce, una benedizione che segue. La chiamata iniziale non è quindi un evento isolato, ma l'inizio di un'esistenza interamente strutturata dall'ascolto e dalla fiducia. Abramo non obbedisce una volta per tutte; entra in un modo di vivere in cui l'obbedienza diventa il suo respiro naturale.
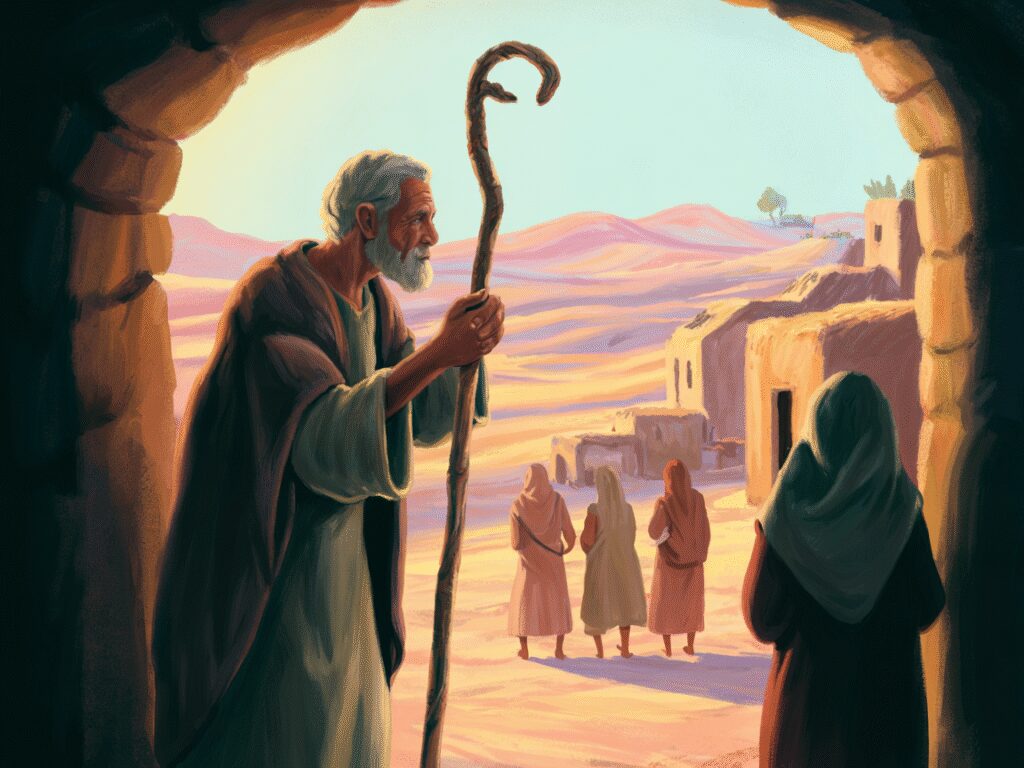
Analisi: la fede come resa fiduciosa
Il paradosso di Abramo
Al centro dell'esperienza di Abramo c'è un luminoso paradosso che percorre tutta la Bibbia: possediamo veramente solo ciò che siamo disposti a perdere; riceviamo pienamente solo ciò che cessiamo di voler controllare. Questo principio controintuitivo si scontra con la nostra logica naturale, che cerca di accumulare, proteggere e controllare. Abramo avrebbe potuto calcolare: sono vecchio, non ho figli, possiedo proprietà, perché rischiare tutto questo per una vaga promessa? Ma la fede non calcola, si fida. Non misura le probabilità; si abbandona alla fedeltà divina.
Questo paradosso trova la sua formulazione più radicale nell'episodio del sacrificio di Isacco. Dio chiede ad Abramo di sacrificare il figlio della promessa, colui attraverso il quale tutto ciò che era stato annunciato si sarebbe compiuto. La logica umana crolla: come può la promessa realizzarsi se il suo unico erede viene messo a morte? Eppure Abramo obbedisce, convinto che Dio possa risuscitare i morti o trovare un'altra via impossibile. La fede non è irrazionale ma sovra-razionale: non nega la ragione, ma la porta attraverso abissi che l'intelligenza da sola non potrebbe superare.
L'obbedienza come libertà
Un malinteso moderno vede l'obbedienza come alienazione, una sottomissione servile che schiaccia la libertà personale. L'esperienza di Abramo rivela esattamente il contrario: l'obbedienza a Dio libera da una servitù umana ben più opprimente. Lasciando Ur, Abramo si libera dall'idolatria, dal conformismo sociale e dal determinismo familiare. Seguendo una chiamata trascendente, sfugge alle pressioni immanenti che avrebbero dettato la sua esistenza. L'obbedienza biblica non è una cieca sottomissione al potere arbitrario, ma una libera risposta a un amore che chiama.
Questa nuova libertà si manifesta nella capacità di Abramo di vivere in un'attesa attiva. Non possiede ancora la terra, ma vi vive come uno straniero, piantando la sua tenda, edificando altari e affermando la sua presenza senza violenza. Non ha ancora discendenti, ma crede nella promessa, al punto che sarà chiamato "padre di una moltitudine" prima ancora di avere un secondo figlio. Questa vita nel "non ancora" non è una sterile frustrazione, ma una fecondità di altro ordine. Abramo scopre che si può vivere delle promesse di Dio come altri vivono dei propri beni, e persino con maggiore intensità, perché l'attesa approfondisce il desiderio mentre il possesso lo smorza.
La benedizione che circola
La seconda parte della chiamata è spesso meno notata, ma altrettanto essenziale: "Diventerai una benedizione […] In te saranno benedette tutte le famiglie della terra". Abramo non è benedetto solo per se stesso, ma per diventare canale di benedizione per tutta l'umanità. Questa dimensione universale dell'elezione particolare rivela la logica divina: Dio sceglie di servire, benedice affinché la benedizione circoli, dona affinché altri donino a loro volta. L'elezione non è mai un privilegio egoistico, ma sempre una responsabilità missionaria.
Questa vocazione universale, inscritta nella chiamata di Abramo, troverà il suo compimento ultimo in Gesù Cristo, discendente di Abramo secondo la carne, ma fonte di benedizione per tutte le nazioni secondo lo Spirito. San Paolo svilupperà questa teologia mostrando che tutti coloro che hanno fede sono figli di Abramo, qualunque sia la loro origine etnica. La benedizione abramitica non intendeva quindi chiudersi a un popolo particolare, ma aprirsi gradualmente all'umanità universale. Abramo diventa così non solo il padre del popolo ebraico, ma anche il padre di tutti i credenti, il prototipo dell'uomo giustificato dalla fede e non dalle opere della legge.
Lo sradicamento come condizione di fertilità
Lascia per trovare
Il primo movimento della chiamata – "Vattene dal tuo paese" – non è una punizione, ma una purificazione. Abramo visse in una civiltà brillante, Ur dei Caldei, una delle città più avanzate del suo tempo. Lasciare Ur significava rinunciare alle comodità, alla cultura raffinata, alle strutture sociali consolidate. Ma questi vantaggi esteriori rischiavano anche di soffocare la voce interiore, ingombrando l'ascolto spirituale. Chiedendo ad Abramo di andarsene, Dio non gli toglie qualcosa, ma gli fa spazio per offrirgli infinitamente di più.
Questo sradicamento geografico simboleggia uno sradicamento interiore più profondo: accettare di non essere più definiti dalle proprie origini, dal proprio passato, dai propri successi. L'identità umana naturale si costruisce per accumulazione: si è figli di, cittadini di, eredi di. L'identità spirituale secondo Abramo si costruisce strappandosi da sé: si diventa figli della promessa cessando di essere solo figli della carne; si diventa cittadini del Regno accettando di essere stranieri sulla terra; si eredita Dio rinunciando alle eredità terrene. Questo non è un disprezzo per la creazione, ma una giusta gerarchia di attaccamenti: amare Dio più di ogni altra cosa permette in ultima analisi di amare ogni cosa al suo giusto posto.
L'esilio come pedagogia spirituale
Il tema del pellegrinaggio attraversa tutta la vita di Abramo. Non costruirà mai una casa di pietra nella Terra Promessa, ma vivrà sempre in una tenda. Questa precarietà volontaria non è masochismo, ma una profonda saggezza: chi si stabilisce definitivamente rischia di dimenticare di essere in cammino verso una patria definitiva. La tenda è un richiamo quotidiano alla fragilità, alla dipendenza, alla necessità di affidarsi a Dio per avere protezione e nutrimento. Mantiene viva la consapevolezza che questo mondo non è la meta finale, ma la tappa verso la "città dalle fondamenta incrollabili, il cui costruttore è Dio stesso", come dirà la Lettera agli Ebrei.
Questa spiritualità del pellegrinaggio alimenta un duplice atteggiamento apparentemente contraddittorio: impegno nel presente e distacco dal presente. Abramo si investe pienamente nella sua vita terrena – alleva greggi, negozia alleanze, compra una tomba, sposa suo figlio – ma senza mai limitarsi ad essa come in un assoluto. Compie il suo dovere di uomo senza dimenticare la sua vocazione di straniero. Si prende cura delle realtà terrene senza esserne schiavo. Questa libertà interiore in mezzo agli impegni esteriori caratterizza l'autentica santità: essere pienamente presenti nel mondo senza esserne posseduti.
La paradossale fertilità del vuoto
Lo sradicamento di Abramo crea un vuoto doloroso, ma è proprio questo vuoto che Dio colmerà in modo nuovo. Finché Abramo rimase a Ur, circondato dalla sua famiglia allargata, dalle sue tradizioni ancestrali, dalle sue certezze culturali, non c'era spazio per una novità radicale. Accettando il vuoto – vuoto geografico, vuoto genealogico (non ha figli), vuoto di garanzie – Abramo apre uno spazio in cui Dio può agire creativamente. La sterilità di Sara diventerà il luogo di una nascita miracolosa; il deserto del Negev diventerà teatro di incontri divini; la solitudine dell'esilio diventerà il crogiolo di una nuova intimità con Dio.
Questo principio spirituale rimane eternamente valido: Dio riempie solo le mani vuote, parla veramente solo ai cuori silenziosi e guida solo coloro che accettano di non conoscere più la via. La nostra pienezza umana – intellettuale, emotiva, materiale – può diventare un ostacolo se ci dà l'illusione di autosufficienza. L'autosvuotamento abramitico non è una negazione dei beni terreni, ma una rinuncia a trovare in essi la nostra sicurezza ultima. È accettare di essere poveri davanti a Dio per ricevere da Lui ciò che non potremmo mai dare a noi stessi.

La promessa come dinamica esistenziale
Vivere più dal futuro che dal passato
Abramo inaugura un modo di vivere radicalmente nuovo: vivere orientati al futuro di Dio piuttosto che al passato dell'umanità. Le società tradizionali traggono la loro legittimità dalla tradizione, dall'antichità e dalla ripetizione dell'uguale. Con Abramo inizia una storia aperta a un futuro imprevedibile, guidata da una promessa sempre in avanti. La sua vita non è più determinata da ciò che è stato ma da ciò che sarà; non dall'eredità ricevuta ma dalla missione da compiere; non dalla riproduzione dell'uguale ma dalla generazione del nuovo.
Questo orientamento al futuro trasforma profondamente il rapporto con il tempo. Il credente abramitico non subisce passivamente lo scorrere del tempo; lo abita attivamente come spazio di maturazione della promessa. Ogni giorno non è semplicemente una ripetizione del precedente, ma un passo avanti verso il compimento annunciato. L'attesa non è vuota, ma gravida: porta in sé qualcosa che nascerà. Questa pazienza attiva si oppone sia all'impazienza moderna, che vuole tutto e subito, sia alla rassegnazione fatalista, che non si aspetta più nulla.
La fede come certezza delle realtà invisibili
La Lettera agli Ebrei definisce la fede come "fondamento delle cose che si sperano, dimostrazione di quelle che non si vedono". Abramo illustra perfettamente questa definizione paradossale. Non ha prove tangibili che la promessa si realizzerà, eppure si comporta come se si fosse già realizzata. È chiamato "padre di molti" nonostante abbia un solo figlio, e anche in questo caso per un miracolo tardivo. Questa anticipazione non è illusione, ma fede: la capacità di vedere l'invisibile, di udire il silenzioso, di toccare l'intangibile, perché ci fidiamo della Parola di Dio più che dell'evidenza dei nostri sensi.
Questa certezza non nasce da uno sforzo di volontà con cui Abramo si sforza di credere. Essa scaturisce dall'incontro personale con Dio, un incontro ripetuto per tutta la sua vita. In ogni tappa cruciale – a Sichem, a Betel, a Mamre, alla quercia di More, al monte Moria – Dio si manifesta ad Abramo, gli parla, conferma la sua promessa. La fede, quindi, non è un'adesione astratta a dottrine, ma una relazione viva con Qualcuno che si rivela progressivamente. Abramo non crede in proposizioni, ma in una Persona; non si fida di un sistema, ma di un volto.
Pazienza che matura la promessa
Tra la chiamata iniziale a settantacinque anni e la nascita di Isacco a cento, trascorrono venticinque anni. Venticinque anni di attesa, di speranza, a volte di dubbio, spesso di incomprensione. Perché Dio impiega così tanto tempo per realizzare ciò che ha promesso? Questa lunga gestazione non è un ritardo, ma una maturazione. Dio non fa aspettare Abramo per sadismo, ma per pedagogia: purifica il suo desiderio, approfondisce la sua fede, amplia la sua capacità di ricevere. Se Isacco fosse nato subito, Abramo avrebbe potuto considerarlo frutto del suo vigore naturale. Nascendo miracolosamente da un corpo centenario e da un grembo sterile, Isacco porta nella sua carne il segno indiscutibile dell'intervento divino.
Questa pedagogia divina dell'attesa si ritrova in tutta la storia della salvezza. I patriarchi hanno atteso la terra promessa per generazioni; Israele ha atteso il Messia per secoli; la Chiesa attende il ritorno di Cristo da due millenni. Quest'attesa non è un tempo di riposo, ma un tempo di crescita. Insegna l'umiltà: non si dettano scadenze a Dio; la fiducia: Dio non dimentica ciò che ha promesso; la speranza: ciò che tarda ad arrivare sarà tanto più prezioso quando accadrà. L'attesa crea un vuoto dentro di noi che solo Dio può colmare; dilata i nostri cuori affinché possano accogliere più di quanto immaginassero.
Elezione per la missione universale
Scelto per servire
Un tragico equivoco attraversa la storia delle religioni: confondere l'elezione con il privilegio esclusivo, la scelta divina con il disprezzo per gli altri. La chiamata di Abramo rivela una logica esattamente opposta: egli è scelto non per essere separato dall'umanità, ma per essere al servizio dell'umanità; è benedetto non per conservare la benedizione, ma per trasmetterla; diventa particolare affinché l'universale possa raggiungerlo. La benedizione di Abramo non è mai un tesoro da accumulare, ma un fiume da far scorrere verso tutte le nazioni.
Questa struttura di elezione per la missione illumina tutta la teologia biblica. Israele sarà scelto non perché sia più grande o più giusto degli altri popoli, ma proprio perché è piccolo, affinché la sua futura grandezza manifesti chiaramente l'azione di Dio e non il merito umano. I profeti, gli apostoli, i santi sono tutti scelti secondo questa stessa logica: non per la loro eccellenza personale, ma per il servizio che possono rendere. Anche Cristo, l'Eletto per eccellenza, viene "non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti".
La benedizione che si moltiplica
L'economia divina della benedizione obbedisce a una logica di sovrabbondanza: più circola, più si moltiplica; più è condivisa, più si intensifica. Abramo è benedetto per benedire; riceve per dare; si arricchisce per arricchire. Questa circolazione della benedizione si oppone radicalmente alla logica economica terrena, dove accumulare significa trattenere e condividere significa impoverire. Nell'economia divina, dare arricchisce e trattenere impoverisce; chiudersi inaridisce e aprirsi rinvigorisce.
Questa legge spirituale si verifica concretamente nella vita di Abramo. Quando mostra generosità a Lot, lasciandogli scegliere la parte migliore della terra, Dio gli conferma immediatamente che l'intera terra gli apparterrà. Quando intercede per Sodoma e Gomorra, nonostante queste città vengano infine distrutte, la sua preghiera rivela un cuore dilatato alle dimensioni della compassione divina. Quando accoglie i tre misteriosi visitatori a Mamre, riceve l'annuncio della nascita di Isacco. Ogni gesto di apertura, condivisione e intercessione amplia il canale attraverso il quale la benedizione divina può fluire verso di lui e attraverso di lui.
Padre di tutti i credenti
San Paolo svilupperà magnificamente questa dimensione universale della vocazione abramitica nelle lettere ai Romani e ai Galati. Abramo credette prima di essere circonciso; fu giustificato per fede prima di ricevere la legge. Diventa così il padre spirituale non solo degli ebrei circoncisi, ma di tutti coloro che credono, indipendentemente dalla loro origine etnica. La paternità di Abramo trascende le generazioni biologiche per generare una famiglia spirituale universale. Tutti coloro che confidano in Dio come Abramo confidò in Lui diventano suoi figli e figlie per fede.
Questa apertura universale realizza la promessa iniziale: «In te saranno benedette tutte le famiglie della terra». Cristo Gesù, discendente di Abramo, diventa il mediatore attraverso il quale questa benedizione raggiunge effettivamente tutte le nazioni. La croce di Cristo squarcia il velo che separava ebrei e pagani; la Risurrezione inaugura una nuova creazione dove «non c'è più né Giudeo né Greco». La Chiesa nascente, composta da tutte le nazioni, manifesta visibilmente il compimento della promessa fatta ad Abramo: la sua posterità spirituale è numerosa come le stelle del cielo e la sabbia della spiaggia.
Tradizione spirituale
I Padri della Chiesa e Abramo
La tradizione patristica ha meditato instancabilmente sulla figura di Abramo, vedendo in lui sia un modello di vita spirituale sia una prefigurazione dei misteri cristiani. Sant'Agostino sottolinea che la fede di Abramo «non si stupisce dell'immensità delle promesse»: egli accoglie la Parola divina con semplicità e grandezza, senza misurare la distanza tra l'annuncio e il suo compimento. Questa semplicità non è ingenuità, ma profondità: chi conosce veramente Dio sa che nulla è impossibile a Dio.
San Cirillo d'Alessandria sviluppa una lettura tipologica del sacrificio di Isacco: Abramo rappresenta Dio Padre che consegna il suo unico Figlio; Isacco porta la legna del sacrificio come Gesù porterà la croce; l'ariete provvidenziale prefigura il Cristo sostitutivo. Questa lettura simbolica non nega la storicità del racconto, ma ne rivela il significato teologico: l'intera storia di Abramo è orientata verso Cristo e può essere pienamente compresa solo in lui. Sant'Ireneo afferma che Abramo "seguì il Verbo" ancor prima dell'incarnazione, suggerendo che il Cristo preesistente stesse già guidando il patriarca sulle strade di Canaan.
La spiritualità dell'abbandono
La tradizione spirituale cristiana, in particolare a partire dal XVII secolo, ha sviluppato una teologia dell'"abbandono alla Divina Provvidenza" che affonda le sue radici direttamente nell'esperienza abramitica. Jean-Pierre de Caussade, gesuita francese, insegnava che l'abbandono a Dio non è una rassegnazione passiva, ma una fiducia attiva: accettare che Dio guidi ogni cosa, anche ciò che sembra avverso, verso un bene che non possiamo ancora percepire. Come Abramo che partì senza sapere dove stesse andando, il cristiano procede confidando nella sapienza divina piuttosto che nella propria comprensione.
Charles de Foucauld ha condensato questa spiritualità nella sua celebre "Preghiera di abbandono": "Padre mio, mi abbandono a te, fa' di me ciò che vuoi". Questa preghiera riprende la struttura stessa della chiamata di Abramo: rinunciare ai propri progetti per accogliere il progetto di Dio; rinunciare al controllo per entrare nella fiducia; accettare di non comprendere per poter amare totalmente. Santa Teresa di Lisieux parlava della "piccola via", questa fiducia infantile che si rimette nelle mani del Padre senza calcolare o misurare, semplicemente perché sa di essere amata.
La pedagogia divina del distacco
I grandi maestri spirituali, da Giovanni della Croce a Francesco di Sales, hanno tutti meditato sulla necessità del distacco esemplificato da Abramo. Non un distacco gelido che disprezzerebbe le creature, ma un distacco amorevole che le ama in Dio e per Dio piuttosto che in se stesse e per sé. Abramo ama Sara, ma la sua vera sicurezza è in Dio; ama Isacco, ma è pronto a restituirlo a Colui che glielo ha donato; desidera la terra promessa, ma accetta di viverci come uno straniero. Questo distacco paradossale consente un attaccamento più profondo, libero da possessività e ansia.
Questa saggezza spirituale riecheggia le intuizioni più profonde della filosofia: possediamo veramente solo ciò che siamo capaci di perdere senza essere distrutti. Chi non può vivere senza una certa persona, un certo bene, una certa situazione, è in realtà schiavo di ciò che crede di possedere. Abramo, accettando di perdere potenzialmente tutto, scopre di possedere veramente tutto perché possiede Dio, e che chi possiede Dio possiede tutto dentro di sé. "Dio solo basta", direbbe Teresa d'Avila, un'eco lontana della libertà abramitica.
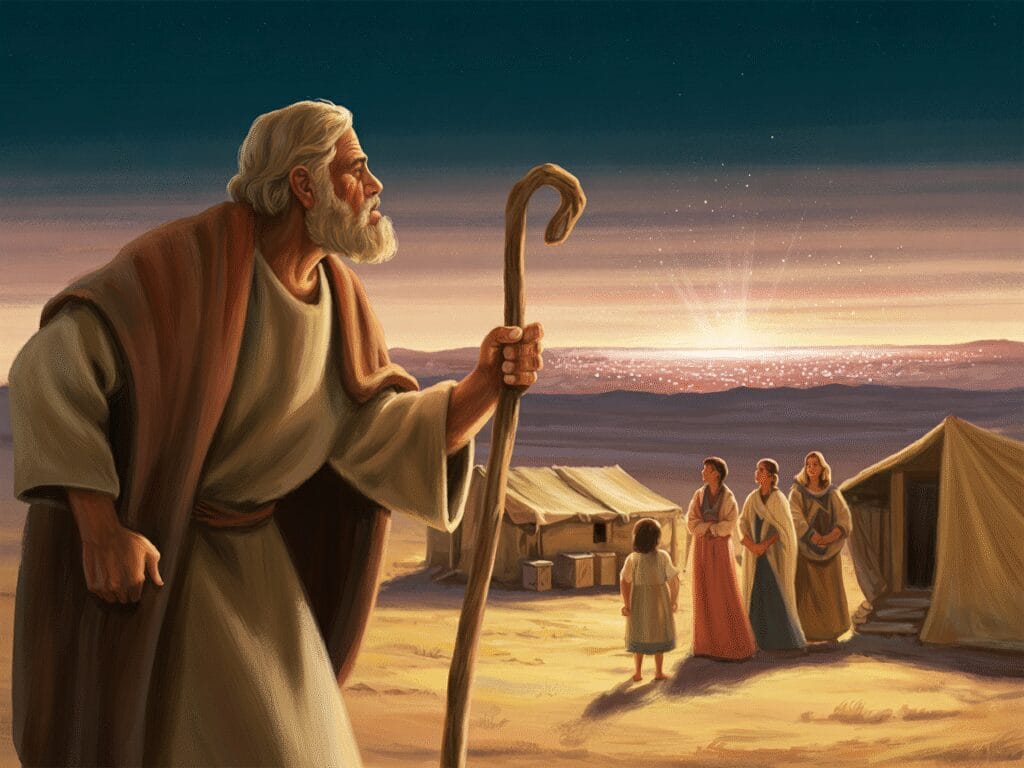
MeditazioneS
Per incarnare la dinamica abrahamitica nella nostra vita concreta oggi, ecco alcuni passaggi pratici su cui meditare e da sperimentare:
Identifichiamo i nostri UR personali. Prendiamoci il tempo di discernere ciò che, nella nostra vita attuale, costituisce le nostre sicurezze umane – relazioni, beni, status, abitudini – a cui forse siamo eccessivamente attaccati. Non per disprezzarle, ma per situarle precisamente in relazione a Dio.
Coltivare l'ascolto interiore. Abramo sentì la chiamata di Dio perché era un buon ascoltatore. Stabilì regolari momenti di silenzio, lontano dal rumore e dalla confusione, affinché la Parola di Dio potesse farsi strada nella nostra coscienza.
Accetta una “piccola deviazione”. Scegli concretamente una rinuncia limitata ma significativa – un'abitudine comoda, una relazione tossica, un progetto che ci appesantisce – come esercizio di obbedienza e fiducia. Lascia un po' per imparare a lasciare di più.
Vivi di promesse piuttosto che di possesso. In situazioni di aspettativa o incertezza, esercitatevi a confidare nella fedeltà di Dio piuttosto che nel vostro controllo. Meditate sulle promesse bibliche come realtà più solide che come prove tangibili.
Diventa un canale di benedizione. Identificare concretamente come possiamo essere una benedizione per gli altri: chi possiamo incoraggiare, aiutare, ascoltare, servire? La benedizione ricevuta deve circolare per non ristagnare.
Vivere come un pellegrino. Anche se viviamo in modo stabile, coltiviamo un atteggiamento interiore di pellegrinaggio: ricordando che questo mondo non è la nostra dimora definitiva, che stiamo camminando verso la Gerusalemme celeste. Questa consapevolezza ridimensiona i fallimenti terreni senza trascurare gli impegni presenti.
Rileggere la nostra storia alla luce della Provvidenza. Guardatevi regolarmente indietro per riconoscere come Dio ha guidato le nostre vite, spesso in modi che non avremmo mai scelto. Questa rilettura rafforza la fiducia per i passi futuri.
Conclusione: l'audacia di rischiare tutto su una Parola
La chiamata di Abramo in Genesi 12:1-2 non è semplicemente un episodio fondamentale nella storia biblica; rivela la struttura continua di ogni esistenza autenticamente spirituale. Partire, avere fiducia, obbedire, attendere, ricevere, trasmettere: questi verbi abramitici delineano il cammino di ogni vita offerta a Dio. Questo cammino non è né comodo né prevedibile, ma è l'unico che conduce alla vera realizzazione.
La nostra epoca dà priorità alla sicurezza, al controllo e a un'attenta pianificazione del futuro. Abramo ci ricorda che esiste un'altra saggezza: l'audacia di rischiare tutto per una Parola, la follia di preferire l'invisibile al visibile, il coraggio di perdere per guadagnare infinitamente di più. Questa saggezza non è riservata a eroi eccezionali, ma è offerta a ogni credente. Dio continua a chiamare, oggi come 4.000 anni fa, uomini e donne a lasciare la loro Ur personale e a marciare verso l'imprevedibile Canaan.
Questa chiamata ci raggiunge nella nostra condizione concreta: nelle nostre paure, nei nostri attaccamenti, nei nostri calcoli prudenti. Ma ci raggiunge anche nel nostro profondo desiderio di una vita che abbia un senso, di un'esistenza al servizio di qualcosa di più grande dei nostri piccoli comfort. Abramo ci insegna che è possibile vivere diversamente, guidati non dall'ansia del domani, ma dalla fiducia in Colui che ha creato tutti i domani. Questa vita di fede non è una fuga dalla realtà, ma un'immersione più profonda nel Reale ultimo, quello che i nostri sensi non percepiscono ancora ma che il nostro cuore può già intuire.
L'invito finale è semplice e radicale: accetteremo, a modo nostro, nel nostro tempo, nelle nostre circostanze particolari, di rispondere come Abramo: "Eccomi"? Questa disponibilità aperta alla chiamata divina, qualunque sia la sua forma concreta, trasforma ogni esistenza in un'avventura spirituale. Ci rende, come Abramo, pellegrini portatori di benedizioni, credenti radicati nell'invisibile, testimoni viventi che Dio mantiene la sua parola e che fidarsi della sua Parola non è mai follia, ma la più alta saggezza.
Pratico
- Medita ogni giorno su Genesi 12:1-9 chiedendo allo Spirito Santo di realizzare questa chiamata nella tua vita personale oggi.
- Praticare un “digiuno di sicurezza” una volta alla settimana: rinunciare al controllo abituale per praticare la fiducia nella Provvidenza divina.
- Tenere un diario spirituale dove annotare le chiamate ricevute, le obbedienze compiute, i frutti osservati dalla fiducia in Dio nel corso dei mesi.
- Leggi Ebrei 11 a complemento: la galleria dei testimoni della fede che, tutti, a loro modo, hanno imitato Abramo nel loro cammino spirituale.
- Scegliere un “compagno di viaggio abramitico” : un amico o una guida spirituale con cui condividere le tappe del pellegrinaggio interiore e incoraggiarsi a vicenda.
- Praticare l'intercessione universale come Abramo che prega per Sodoma: allarga la sua preghiera oltre la sua cerchia immediata per farla diventare un canale di benedizione.
- Coltivare la virtù dell'ospitalità che Abramo praticò magnificamente a Mamre: accogliere lo straniero è talvolta accogliere Dio stesso in un volto inaspettato.
Riferimenti
Principali testi biblici
- Genesi 12:1-9 (Chiamata e partenza di Abramo)
- Genesi 15 (il patto divino e la promessa della discendenza)
- Genesi 22 (il sacrificio di Isacco e la fede suprema)
- Romani 4 (Abramo giustificato per fede, non per opere)
- Galati 3:6-9 (tutti i credenti sono figli di Abramo per fede)
- Ebrei 11:8-19 (Abramo, modello di fede per la Chiesa)
tradizione patristica
- Sant'Agostino, Sermoni sulla Genesi (commenti su Abramo)
- San Cirillo d'Alessandria, Glafira in Genesi (lettura tipologica)
- Sant'Ireneo di Lione, Contro le eresie (Abramo seguendo la Parola)
spiritualità cristiana
- Jean-Pierre de Caussade, Arrendersi alla Divina Provvidenza (XVIII secolo)
- Charles de Foucauld, Preghiera di abbandono e scritti spirituali
- Teresa di Lisieux, Storia di un'anima (il piccolo sentiero della fiducia)
Studi teologici contemporanei
- Commentari biblici sulla Genesi (esegesi storico-critica e spirituale)
- Teologia del Patto (prospettiva riformata e cattolica)
- Studi sulla fede abramitica nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'Islam