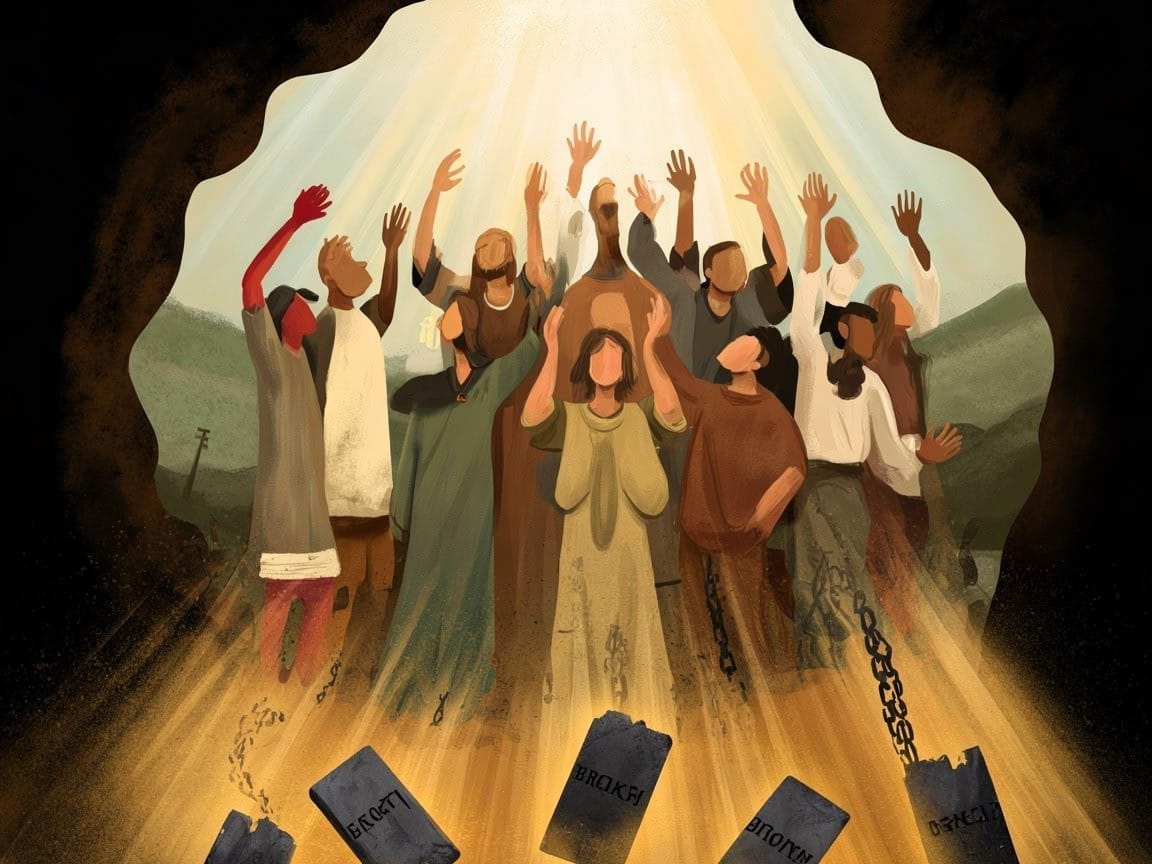Lettura della lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli,
il peccato non deve regnare nel tuo corpo mortale
e ti farà obbedire ai suoi desideri.
Non offrite le membra del vostro corpo al peccato
come armi al servizio dell'ingiustizia;
al contrario, presentatevi a Dio
come i vivi tornati dai morti,
presenta le tue membra a Dio
come armi al servizio della giustizia.
Perché il peccato non avrà più potere su di voi:
perché non siete più soggetti alla Legge,
siete soggetti alla grazia di Dio.
E allora? Poiché non siamo soggetti alla Legge
ma alla grazia,
commetteremo peccato?
Non c'è modo.
Non lo sai?
Colui al quale vi presentate come schiavi
per obbedirgli,
è da colui al quale obbedisci,
che siete schiavi:
o dal peccato, che porta alla morte,
o l'obbedienza a Dio, che conduce alla giustizia.
Ma rendiamo grazie a Dio:
voi che eravate schiavi del peccato,
ora hai obbedito con tutto il tuo cuore
al modello presentato dall'insegnamento che vi è stato trasmesso.
Liberati dal peccato,
siete diventati schiavi della giustizia.
– Parola del Signore.
Come Alive: La rivoluzione interiore della grazia secondo San Paolo
Come passare dalla schiavitù del peccato alla libertà radicale del risorto
Nella sua lettera ai Romani, San Paolo lancia un appello toccante: presentarci a Dio come risorti. Questo invito non è una pia metafora, ma un programma di trasformazione radicale. Di fronte ai cristiani di Roma tentati dal compromesso morale, l'apostolo rivela una verità liberatrice: la grazia non fa a meno dell'etica; la rende finalmente possibile. Per ogni credente che cerca di vivere la propria fede in modo autentico, questo brano offre una chiave decisiva: comprendere che la vita cristiana non è uno sforzo morale eroico, ma una rinascita che impegna tutto il nostro essere nella lotta per la giustizia.
Dopo aver collocato questo testo nel grande dibattito paolino sulla grazia e la Legge, esploreremo il paradosso centrale: la libertà cristiana che diventa servitù volontaria. Spiegheremo poi tre assi principali: la risurrezione come evento presente, il corpo come territorio spirituale e l'obbedienza liberatrice. Infine, ascolteremo le risonanze di questa parola nella tradizione cristiana prima di proporre percorsi concreti per metterla in pratica.

Contesto
Il capitolo 6 della Lettera ai Romani costituisce un momento cruciale nell'argomentazione di san Paolo. Avendo stabilito nei capitoli precedenti che la salvezza viene dalla sola fede e non dalle opere della Legge, l'apostolo anticipa una formidabile obiezione: se la grazia abbonda dove è abbondato il peccato, perché non continuare a peccare affinché la grazia si manifesti maggiormente? Questa domanda, che potrebbe sembrare assurda, in realtà rivela una tentazione permanente: quella di trasformare la libertà cristiana in licenza morale.
Paolo scrisse ai Romani intorno agli anni 57-58, da Corinto, a una comunità che non aveva ancora visitato ma di cui era consapevole delle tensioni. Roma era allora sede di una Chiesa composita, che riuniva giudeo-cristiani legati alla Torah e cristiani pagani recentemente convertiti. La questione dell'articolazione tra grazia e moralità non era oggetto di speculazione teologica, ma toccava la vita quotidiana di questi credenti: come vivere da cristiani nella capitale dell'Impero, circondati da templi pagani e pratiche immorali?
Il brano che abbiamo davanti fa parte di una dimostrazione concreta. Paolo ha appena spiegato che attraverso il battesimo, il cristiano muore e risorge con Cristo. Questa unione con Cristo crocifisso e risorto non è simbolica: opera una rottura ontologica con la vecchia vita. Il vecchio uomo fu crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse distrutto. D'ora in poi, la persona battezzata appartiene a un nuovo ordine, quello della risurrezione.
Nel nostro brano, l'apostolo trae conseguenze pratiche da questa verità teologica. Utilizza un linguaggio marziale di grande impatto: le membra del corpo sono descritte come armi che possono essere messe al servizio di schieramenti contrapposti. Questa militarizzazione del linguaggio non è casuale. Paolo, cittadino romano, conosce bene l'organizzazione legionaria e usa questa immagine per dimostrare che la neutralità è impossibile: si deve necessariamente servire un padrone, o il peccato, che conduce alla morte, o Dio, che conduce alla giustizia.
La struttura retorica del brano rivela la pedagogia paolina. Innanzitutto, un imperativo negativo: non lasciate regnare il peccato. Poi un duplice movimento: non offrite le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi a Dio. Poi, una giustificazione teologica: non siete più sotto la Legge, ma sotto la grazia. Poi un'obiezione anticipata e la sua confutazione. Infine, un atto di ringraziamento e una descrizione della nuova condizione del credente.
Questo testo appartiene al genere dell'esortazione morale, ma si distingue dalla semplice parenesi per il suo ancoraggio cristologico e battesimale. Paolo non propone una morale naturale accessibile attraverso la ragione, ma un'etica radicata nell'evento pasquale. La trasformazione morale scaturisce dall'unione mistica con Cristo. È questa articolazione tra indicativo teologico e imperativo etico che rende la morale paolina unica e potente.

Analisi
Il cuore del nostro brano risiede in un'affermazione paradossale che capovolge tutte le nostre categorie: la vera libertà consiste nel farsi schiavi di Dio. Per comprendere questo rovesciamento, dobbiamo cogliere la visione antropologica di Paolo. L'uomo non esiste mai in uno stato di assoluta autonomia. È già sempre impegnato in una relazione di dipendenza. L'unica domanda è: a chi appartiene?
Questa tesi è in diretta opposizione all'ideale di autonomia che struttura il pensiero greco e, più tardi, la modernità. Per Paolo, la richiesta di radicale indipendenza costituisce proprio la forma suprema di alienazione. Rifiutandosi di servire Dio, l'uomo non conquista la propria libertà: si sottomette al peccato, un tiranno ben più implacabile. Il peccato, nella teologia paolina, non è principalmente una colpa morale, ma un potere cosmico che schiavizza l'umanità. È una forza personale, quasi personificata, che regna e fa regnare la morte.
La dinamica del testo rivela un movimento di liberazione in tre fasi. Prima fase: la consapevolezza. Paolo sfida i suoi lettori: Non sapete? Questa domanda retorica presuppone che la verità sia già nota ma non pienamente appropriata. Il cristiano possiede una conoscenza salvifica, ma deve permetterle di trasformare la sua esistenza concreta. Seconda fase: il ringraziamento. Rendiamo grazie a Dio: la liberazione non viene dallo sforzo umano ma dall'iniziativa divina. Richiede gratitudine, non orgoglio. Terza fase: il riorientamento pratico. Presentatevi a Dio: la libertà acquisita deve essere attivata da una scelta quotidiana.
L'espressione più suggestiva resta quella dei vivi ritornati dalla morte. Paolo non dice: presentatevi come vivi che sfuggono alla morte, ma come vivi che sono già passati attraverso la morte e sono tornati. Questa sfumatura è cruciale. Significa che la vita cristiana non è una fuga dalla morte, ma una vita vinta sulla morte, una vita che ha attraversato la morte ed è uscita vittoriosa. Il Battesimo ha operato questo passaggio: immerso nella morte di Cristo, il credente risorge a una vita nuova.
Questa nuova vita ha una qualità diversa dall'ordinaria esistenza biologica. Partecipa già alla vita eterna; è vita secondo lo Spirito, vita orientata a Dio. Da qui l'esigenza etica che ne consegue naturalmente: poiché siete risorti, vivete come risorti. L'imperativo deriva dall'indicativo. Non è: sforzatevi di risorgere vivendo moralmente; è: poiché siete risorti, la vita morale diventa possibile e necessaria.
Il contrasto tra Legge e grazia illumina questa nuova possibilità. Sotto la Legge, l'uomo conosceva il bene ma non poteva compierlo. La Legge rivelava il peccato senza fornire la forza per superarlo. Prescriveva ma non trasformava. La grazia, al contrario, cambia la condizione del soggetto morale. Non indica semplicemente la via; dona la capacità di percorrerla. Crea un uomo nuovo, capace di un'obbedienza che non è più costrizione esterna ma adesione interiore.
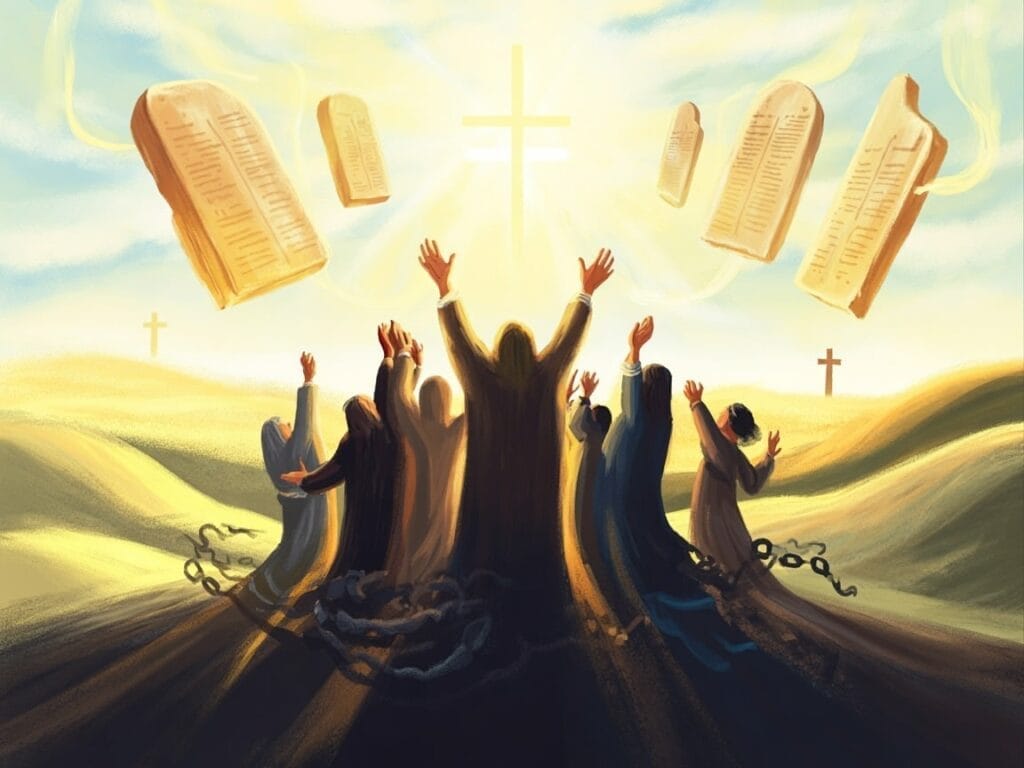
La Resurrezione: un evento presente, non un evento futuro
Quando Paolo parla del ritorno dei vivi dai morti, non proietta questa risurrezione in un lontano aldilà. Afferma che è già avvenuta, sacramentalmente, nelle acque del battesimo. Questa affermazione contrasta la nostra tendenza a relegare le grandi promesse cristiane a un confortevole futuro escatologico. La risurrezione non è solo la speranza che consola; è la realtà che trasforma l'oggi.
Questa rilevanza della risurrezione spiega l'urgenza della chiamata di Paolo. Se siamo già risorti, allora ogni momento che viviamo secondo l'antica logica del peccato costituisce una contraddizione insopportabile. È come se un prigioniero liberato scegliesse di rimanere nella sua cella. La porta è aperta, le catene sono spezzate, ma dobbiamo osare varcare la soglia, per abitare veramente la libertà che abbiamo conquistato.
I Padri della Chiesa hanno magnificamente sviluppato questa teologia della risurrezione presente. Per loro, il cristiano vive tra due risurrezioni: quella del battesimo, già compiuta, e quella della carne, ancora attesa. Tra le due si distende il tempo della Chiesa, un tempo di crescita verso la piena manifestazione di ciò che è già donato in germe. Sant'Agostino paragona questa situazione a quella di un erede che possiede già il titolo di proprietà ma non è ancora entrato nel godimento della sua eredità.
Concretamente, vivere da risorti significa adottare il comportamento di chi non teme più la morte. I martiri hanno illustrato questa logica fino in fondo: per chi è già passato attraverso la morte con Cristo, la morte fisica perde il suo pungiglione. Diventa un passaggio e non una rottura. Ma questa vittoria sulla morte si esercita anche nelle piccole morti quotidiane: accettare di rinunciare ai propri ingiusti privilegi, perdonare invece di vendicarsi, donare senza calcolare il ritorno. Ognuno di questi atti proclama: vivo una vita che non teme più la morte.
La risurrezione attuale trasforma anche il nostro rapporto con il tempo. Introduce una dimensione di eternità nel tempo cronologico. Il risorto abita già il Regno mentre cammina ancora su questa terra. È cittadino di due città, ma la sua vera patria è quella celeste. Questa duplice appartenenza non porta al disprezzo per il mondo terreno; al contrario, è proprio perché partecipa già alla vita eterna che il cristiano può impegnarsi pienamente per la giustizia nella storia, senza essere schiacciato dall'assurdo o dalla disperazione. Sa che la morte non ha l'ultima parola, che l'amore è più forte, che il bene trionferà.
Questa speranza attiva distingue radicalmente il cristiano dall'ottimista ingenuo e dal pessimista disilluso. Egli non ignora il male; ne osserva addirittura l'enorme potenza nella storia e nei cuori. Ma sa che il male è già stato sconfitto, anche se la vittoria non è ancora pienamente manifesta. Combatte quindi con la certezza del soldato che sa che l'esito della guerra è già deciso, anche se restano battaglie da combattere.
Il corpo: territorio spirituale e campo di battaglia
Paolo usa un vocabolario corporeo molto preciso. Non parla dell'anima o dello spirito in opposizione al corpo, ma delle membra del corpo come strumenti che possono essere diretti. Questa attenzione al corpo merita attenzione, perché contraddice il dualismo che ha spesso contaminato la spiritualità cristiana.
Per l'apostolo, il corpo non è la prigione dell'anima; è il luogo stesso della vita spirituale. È con il suo corpo che il cristiano serve Dio o il peccato. Le membra del corpo – mani, piedi, bocca, occhi – diventano armi nel combattimento spirituale. Questo vocabolario militare indica che il corpo è un campo di battaglia, un territorio conteso tra due regni opposti.
Questa visione ha immense conseguenze pratiche. Significa, innanzitutto, che la santità non è una questione di pure intenzioni, ma di azioni concrete. Ciò che faccio con il mio corpo impegna il mio destino spirituale. I gesti contano: dove muovo i miei passi, cosa tocco con le mie mani, le parole che escono dalla mia bocca. La morale cristiana non è idealistica; è incarnata. Non disprezza la materia, ma la prende sul serio come luogo di obbedienza o ribellione.
Questo approccio valorizza poi le pratiche corporee della spiritualità: il digiuno, l'elemosina, il pellegrinaggio, la prostrazione, i gesti liturgici. Queste pratiche non sono accessori folkloristici; sono modi di presentare concretamente il proprio corpo a Dio. Quando mi inginocchio per pregare, il mio corpo confessa che Dio è grande e io sono piccolo. Quando tendo la mano per fare l'elemosina, il mio braccio diventa strumento della carità divina. Quando mi astengo dal cibo per digiunare, il mio stomaco impara la padronanza spirituale.
Questa teologia del corpo getta luce anche sulla morale sessuale cristiana, così spesso fraintesa. Se il corpo è un membro di Cristo, un tempio dello Spirito Santo, allora certi usi del corpo diventano impossibili non per puritanesimo, ma per coerenza ontologica. Non si possono unire le membra di Cristo a una prostituta, aveva già detto Paolo ai Corinzi. Non è che la sessualità sia cattiva, è che coinvolge così tanto il corpo che il suo significato va ben oltre il semplice piacere fisico.
La sapienza paolina sul corpo è equidistante da due errori opposti. Da un lato, l'angelismo, che vorrebbe ignorare il corpo e vivere una spiritualità disincarnata. Dall'altro, il materialismo, che riduce l'uomo al suo corpo biologico e nega qualsiasi dimensione trascendente. Paolo afferma: il tuo corpo è destinato alla risurrezione, è chiamato a partecipare alla gloria divina, quindi trattalo con il rispetto dovuto a un santuario, pur riconoscendo che deve essere sottomesso allo spirito.
Liberare l'obbedienza: il paradosso della servitù volontaria
La formula paolina più paradossale rimane questa: liberati dal peccato, siete diventati schiavi della giustizia. Come può la schiavitù essere libertà? Non è forse una contraddizione in termini? Per comprendere questo paradosso, dobbiamo distinguere tra due tipi di servitù.
La prima schiavitù, quella del peccato, è subita. Nessuno sceglie deliberatamente di essere schiavo del male. Ci cadiamo dentro, vi scivoliamo dentro, vi restiamo impantanati. Sant'Agostino ha descritto magnificamente questo stato nelle sue Confessioni: Volevo il bene e ho fatto il male, incatenato dalle mie abitudini, prigioniero delle mie passioni. Questa schiavitù al peccato è caratterizzata da costrizione, alienazione e perdita di autocontrollo. L'uomo peccatore non è libero; è trascinato dai suoi desideri, manipolato dalle sue paure, determinato dalle sue dipendenze.
La seconda servitù, quella della giustizia, è scelta. È un'obbedienza libera, una sottomissione volontaria. Assomiglia all'impegno del musicista che si sottomette alle regole dell'armonia non per costrizione, ma perché sa che questa disciplina è una condizione della sua libertà creativa. O ancora, all'atleta che si sottopone a un allenamento rigoroso perché mira alla vittoria. In entrambi i casi, la regola accettata libera piuttosto che alienare.
Paolo precisa: avete obbedito con tutto il cuore al modello presentato dall'insegnamento. L'obbedienza cristiana non è cieca sottomissione a un'autorità arbitraria. È adesione cordiale a un modello, quello di Cristo. La parola greca per modello evoca un'impronta, un sigillo che lascia il segno. Il battezzato riceve l'impronta di Cristo, si configura a Lui, diventa sua immagine. Da allora in poi, obbedire all'insegnamento cristiano significa diventare pienamente se stessi, realizzare la propria vocazione più profonda.
Questa obbedienza liberatrice si manifesta nelle scelte concrete della vita. Ogni volta che scelgo la verità invece di comode menzogne, libero la mia parola dalla schiavitù dell'inganno. Ogni volta che scelgo la fedeltà nonostante il fascino di facili avventure, libero la mia capacità di amare veramente. Ogni volta che pratico la giustizia invece di cercare il mio interesse, mi libero dall'egoismo che mi opprime.
La tradizione spirituale cristiana ha sviluppato un'intera pedagogia dell'obbedienza. I voti monastici di obbedienza mirano proprio a questa libertà paradossale. Rinunciando alla propria volontà, il monaco scopre la vera libertà dei figli di Dio. Impara a volere ciò che Dio vuole e, in questa unificazione della volontà, trova la pace. Non è più la guerra perpetua tra ciò che devo fare e ciò che voglio fare. È l'armonia tra desiderio e dovere.
Per il cristiano nel mondo, questa obbedienza liberatrice si esercita in modo diverso, ma secondo la stessa logica. Si tratta di presentare ogni giorno a Dio le proprie scelte, decisioni e azioni, allineandole alla volontà divina conosciuta dalla coscienza, dalla Scrittura e dall'insegnamento della Chiesa. Questa presentazione quotidiana crea gradualmente una seconda natura, un'abitudine alla santità. Ciò che era sforzo diventa spontaneità, la virtù matura in saggezza.

Tradizione e fonti
La teologia paolina della grazia liberatrice ha profondamente influenzato l'intera tradizione cristiana, in particolare attraverso due figure di spicco: Sant'Agostino e Martin Lutero. Agostino, nella sua controversia contro i Pelagiani, sviluppò la dottrina della grazia efficace che trasforma veramente la volontà umana. Per lui, la grazia non è semplicemente un aiuto esterno allo sforzo morale; è una forza interiore che guarisce la volontà ferita dal peccato e la rende capace di amare veramente Dio.
Gli scritti agostiniani sulla libertà cristiana riecheggiano esattamente la dialettica di Paolo. Nel suo trattato Sulla grazia e il libero arbitrio, Agostino spiega che la vera libertà non è il potere di scegliere tra il bene e il male, ma la capacità di non poter più peccare. Questa libertas a necessitate peccandi, la libertà dalla necessità di peccare, caratterizza i beati in cielo e, in modo anticipato, coloro che vivono sotto la grazia.
Tommaso d'Aquino, nel XIII secolo, integrò questa prospettiva nella sua sintesi teologica. Nella Summa, distinse tra libertas a coactione, la libertà esteriore dalla costrizione che anche il peccatore possiede, e libertas a miseria, la libertà interiore dalla miseria del peccato, che solo la grazia offre. Per Tommaso, la virtù perfetta rende liberi perché armonizza volontà e dovere: la persona virtuosa compie spontaneamente il bene che ama.
La tradizione mistica cristiana ha esplorato le dimensioni pratiche di questa libertà nella grazia. Giovanni della Croce parla dello svuotamento di sé necessario affinché Dio agisca pienamente. Teresa d'Avila descrive le dimore del castello interiore dove l'anima progredisce verso l'unione trasformante. Francesco di Sales insegna la dolcezza dell'obbedienza amorosa. In tutte queste grandi figure spirituali, ritroviamo il tema paolino: abbandonarsi totalmente a Dio significa trovare la vera libertà.
La liturgia battesimale della Chiesa antica illustra perfettamente il nostro passaggio. Il rito includeva una triplice rinuncia: rinuncio a Satana, alle sue pompe e alle sue opere, seguita da una triplice professione di fede: credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Questo doppio movimento risponde esattamente all'esortazione paolina: non presentatevi al peccato, presentatevi a Dio. Il battesimo realizza questo passaggio di fedeltà, questa metanoia radicale che cambia padrone.
I Padri greci svilupparono una teologia della divinizzazione che amplia il pensiero di Paolo. Per loro, essere liberati dal peccato e diventare schiavi della giustizia significa partecipare alla natura divina. La grazia non ci rende semplicemente esseri umani migliori; ci divinizza, ci rende theoi, dèi per partecipazione. Questa audacia teologica affonda le sue radici nella convinzione che la risurrezione di Cristo abbia aperto all'umanità un destino senza precedenti: diventare ciò che Dio è per natura.
Meditazione
Per incarnare concretamente la chiamata di San Paolo a presentarci a Dio come persone risorte, ecco un cammino spirituale in sette tappe, progressive e realistiche:
Primo passo : Ogni mattina, al risveglio, renditi conto che questo giorno è un dono. Di' a te stesso: sono vivo, risorto con Cristo. Questo giorno mi è dato per servire la giustizia. Questa consapevolezza mattutina guida l'intera giornata.
Secondo passo Identifica concretamente le parti del tuo corpo che presenterai a Dio oggi. Dove andranno i miei piedi? Cosa faranno le mie mani? Cosa diranno le mie labbra? Presentale esplicitamente al Signore in una breve preghiera.
Terzo passo : Nei momenti di tentazione o di decisione difficile, ricordati del tuo battesimo. Rinnova interiormente la tua rinuncia a Satana e la tua professione di fede. Questo gesto può essere accompagnato dal segno della croce, memoriale del battesimo.
Quarto passo : Pratica una forma di digiuno o astinenza, anche modesta, per sperimentare fisicamente che non sei schiavo dei tuoi desideri. Può trattarsi di un digiuno alimentare, ma anche di un digiuno mediatico o digitale.
Quinto passo : Scegli un atto concreto di giustizia ogni settimana. Fai l'elemosina, visita un malato, difendi qualcuno che è stato ingiustamente aggredito. Fai dei tuoi membri armi al servizio della giustizia.
Sesto passo La sera, fate un breve esame di coscienza, esaminando le membra del corpo. Come apparivano i miei occhi oggi? Le mie mani hanno servito? La mia bocca ha edificato? Ringraziate per le vittorie, chiedete perdono per le cadute.
Settimo passo : Una volta alla settimana, prenditi più tempo per meditare sul nostro brano di San Paolo. Leggilo lentamente, soffermati su una frase che ti tocca particolarmente, riflettici, chiedi allo Spirito Santo di spostarla dalla mente al cuore, poi dal cuore alle azioni.
Conclusione
L'appello di San Paolo ai Romani risuona oggi con rinnovata urgenza. In un mondo che confonde la libertà con la licenza, che riduce l'autonomia a indipendenza assoluta, le parole dell'apostolo offrono un paradossale cammino di liberazione: la vera libertà si trova nel dono di sé a Dio. Non è un'ulteriore forma di schiavitù; è la fuga da ogni forma di schiavitù.
Vivere da risorti non è questione di impossibile eroismo morale, ma di accogliere la grazia trasformante. La rivoluzione interiore proposta da San Paolo non è un graduale miglioramento dell'uomo vecchio; è una rinascita radicale. Il Battesimo ci ha resi creature nuove. Ora si tratta di lasciare che questa novità invada ogni angolo della nostra esistenza: i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre scelte, le nostre relazioni, i nostri impegni.
Presentare il proprio corpo a Dio come un essere vivente ritornato dai morti significa fare di ogni gesto quotidiano un atto di risurrezione. Significa iscrivere nella carne del mondo la vittoria di Cristo sulla morte. Significa testimoniare che l'amore è più forte di ogni potenza di distruzione. Significa affermare, contro l'evidenza del male che deturpa la storia, che la luce ha già vinto le tenebre.
Questa vita risorta trasforma la società. Uomini e donne che non temono più la morte diventano invincibili nella loro lotta per la giustizia. Possono assumersi tutti i rischi dell'amore perché non calcolano più secondo la logica del mondo. Sono liberi della stessa libertà di Dio, questa libertà che si dona senza contare, che perdona senza limiti, che spera contro ogni speranza.
L'invito di Paolo è quindi una chiamata rivoluzionaria. Una rivoluzione interiore innanzitutto: lasciare che Dio regni in noi anziché peccare. Ma anche una rivoluzione esteriore: trasformare il mondo introducendo la logica del Regno, questa logica dove gli ultimi sono i primi, dove servire è regnare, dove perdere la propria vita è salvarla. Questa è la vocazione cristiana: diventare persone vive che hanno attraversato la morte, persone libere che hanno scelto l'obbedienza, schiavi della giustizia che manifestano la vera libertà dei figli di Dio.
Pratico
- Risveglio Risorto : Inizia ogni giorno ringraziando Dio per il dono della vita e rinnovando l'offerta di sé stessi al suo servizio.
- Memoria battesimale : Fate consapevolmente il segno della croce, ricordando che attraverso il battesimo si è morti e risuscitati con Cristo.
- Esame del corpo :Ogni sera, rivedo le azioni dei miei membri (occhi, mani, bocca) per discernere se hanno servito la giustizia o il peccato.
- Pratica del dare : Compiere ogni settimana un atto concreto di carità o di giustizia che coinvolga il corpo: elemosina, visite, servizio.
- Digiuno liberatorio : Praticare una forma di astinenza regolare per imparare a padroneggiare i desideri e a liberarsi interiormente dai bisogni.
- Meditazione paolina : Leggi e medita lentamente su Romani 6 ogni settimana, chiedendo allo Spirito di portare la Parola nella vita concreta.
- Celebrazione eucaristica :Partecipa regolarmente alla messa in cui si rievoca il mistero pasquale, fonte della nostra risurrezione e della nostra nuova libertà.
Riferimenti
Principali fonti bibliche : Lettera ai Romani, capitolo 6; Lettera ai Galati 5, 1-13 sulla libertà cristiana; Prima lettera ai Corinzi 6, 12-20 sul corpo come tempio dello Spirito.
tradizione patristica : Sant'Agostino, Sulla grazia e il libero arbitrio; San Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera ai Romani.
Teologia medievale : Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, Prima Secundae, Trattato sulla grazia; Bernardo di Chiaravalle, Trattato sulla grazia e il libero arbitrio.
Spiritualità moderna : Martin Lutero, La libertà del cristiano; Giovanni della Croce, La salita al Carmelo; Teresa di Lisieux, Storia di un'anima.
Commentari contemporanei : Romano Guardini, La morte di Socrate e La morte di Cristo; Joseph Ratzinger (Benedetto XVI), Introduzione al cristianesimo; Hans Urs von Balthasar, Il dramma divino.
Studi esegetici : Stanislas Lyonnet, La libertà del cristiano secondo san Paolo; Ceslas Spicq, Teologia morale del Nuovo Testamento.